Itinerario Arabo-Normanno
In
occasione della dichiarazione dell’itinerario arabo-normanno come patrimonio
dell’umanità UNESCO, propongo un approfondimento su tale corrente artistica;
cominciando da un breve excursus storico.
Dopo
aver conquistato il Sud della penisola fino a Reggio, i Normanni volsero lo sguardo
avido di conquista alla Sicilia, già occupata dagli Arabi. Il 10 gennaio 1077
Palermo era nelle loro mani; nel 1129 Ruggero II cingeva a Palermo la corona di
Re e costituiva il Regno di Sicilia. Con sapiente spirito di tolleranza egli
riuscì a fare di tre popolazioni differenti ed ostili, latini, greci e arabi un
popolo solo.
Palermo,
in quel tempo, divenne città dove il mantello arabo ed il turbante musulmano si
mescolavano alla tunica greca, al corto saio italiano e alla maglia di ferro
normanna.
Questo
“miracolo” di saggezza politica come fu chiamato ebbe il riflesso anche nell’arte,
come testimonia la corrente artistica di quegli anni chiamata araba-normanna.
Esempio
più insigne di tale visione è la Cappella Palatina:
Fu
fatta costruire a partire dal 1130 per volere di re Ruggero II di Sicilia e
venne consacrata il 28 aprile 1140 come chiesa privata della famiglia reale. I
lavori furono completati nel 1143. Un'iscrizione trilingue (latino,
greco-bizantino e arabo) sull'esterno della cappella commemora la costruzione
di un horologium nel 1142.
In
epoca rinascimentale, nell'anno 1472 sono documentate le prime attività
lavorative di Domenico Gagini in Sicilia, opera consistente nel recupero e
ripristino di Arabeschi e Intarsi, manufatti marmorei preesistenti.
Le
tre navate sono separate da colonne in granito e marmo cipollino a capitelli
compositi che sorreggono una struttura di archi ad ogiva. Completa la
costruzione la cupola, eretta sopra le tre absidi del santuario. La cupola e il
campanile originariamente erano visibili dall'esterno prima di venire inglobate
nel Palazzo Reale in seguito alle costruzioni successive.
La
cupola, il transetto e le absidi sono interamente decorate nella parte
superiore da mosaici bizantini, tra i più importanti della Sicilia,
raffiguranti il Cristo Pantocratore
benedicente, l'immagine di maggiore impatto
della cappella, gli evangelisti e scene bibliche varie. Il gigantesco Cristo
Pantocratore ha in mano un libro in cui sono scritti i passi del vangelo di
Giovanni: "Io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle
tenebre, ma avrà la luce della vita.", sia in latino che in greco. I
mosaici di datazione più antica sono quelli della cupola, risalenti alla
costruzione originaria. I mosaici della cupola con il Cristo Pantocratore e gli
angeli attorno evocano il Salmo 11,4 :" Il Signore nel tempio santo, il
Signore ha il trono nei cieli".
Il
soffitto in legno della navata centrale e le travature delle altre navate sono
decorate con intagli e dipinti di stile arabo (muqarnas). In ogni spicchio sono
presenti stelle lignee con rappresentazioni di animali, danzatori e scene di
vita della corte islamica e del paradiso com'è descritto nel Corano.
La Cattedrale di Palermo.
Altro monumento che è magnifica espressione della corrente nata dal tentativo dei Normanni, di realizzare una propria visione artistica, utilizzando intelligenze provenienti dal mondo arabo è la Cattedrale di Palermo.
L'origine di essa si perde nei secoli, infatti la prima chiesa venne costruita nell'attuale area a poche centinaia di metri dal primitivo insediamento fenicio - punico dove adesso sorge il Palazzo dei Normanni, lo stesso luogo deputato durante il I, II e III secolo al sacrificio dei primi martiri palermitani oggetto di persecuzioni cristiane operate da Decio e Diocleziano.
Nel 476 in seguito alla cacciata dei Vandali, che avevano occupato la città nel 440, da parte di Odoacre re degli Ostrogoti, Palermo passò sotto la sfera d'influenza dell'impero romano d'oriente, viene quindi edificato un tempio in stile bizantino dedicato alla Vergine Maria Assunta, è edificato sulle rovine del precedente nel 604 del quale sono pervenute la cripta e la pianta basilicale a forma quadrata.
Con l'invasione dell'isola da parte dei Saraceni, nel lungo contesto della dominazione araba, che a Palermo spazia dall'anno 831 al 1072, la chiesa venne trasformata in luogo di culto musulmano, la grande moschea Gami, capace di contenere 7 mila fedeli.

La corte vescovile venne "invitata" ad abbandonare le sedi cittadine, trovando temporaneamente rifugio presso luoghi di culto nella vicina cittadina di Monreale. L'evento determina la costituzione della futura Arcidiocesi di Monreale.
Il ritorno alla sovranità di matrice cristiana e cattolica avvenne con l'avvento dei Normanni grazie al contributo del Gran Conte Ruggero e del fratello Roberto il Guiscardo. Per celebrare la riconquista territoriale dell'isola, la casata degli Altavilla promosse e favorì la costruzione di splendide e monumentali cattedrali normanne in tutte le località teatro delle battaglie più cruente, riservando a Palermo la costruzione più laboriosa ma, altrettanto fastosa. La moschea venne riadattata rapidamente al culto cristiano.
Sotto le dominazioni di normanni e svevi si assiste in città alla pacifica convivenza di un crogiolo di razze rappresentate dalle religioni monoteiste del mondo allora conosciuto: cristiani, musulmani e ebrei. Palermo è capitale del Sacro Romano Impero con Federico II. Per quasi due secoli le arti e l'architettura sono permeate da canoni stilistici tipici del medio oriente amalgamati con le concezioni nordiche e germaniche.
La chiesa è modificata ancora più volte, ma lo sviluppo in pianta della nuova cattedrale è oggetto sempre dei forti influssi religioso - architettonici precedenti. Ripetutamente rimaneggiata e riedificata per svariati eventi, risente anche di interventi dovuti a fenomeni sismici, soprattutto nell'alta torre campanaria slanciata dinanzi al prospetto occidentale.
L'edificio, già felice espressione di molteplici stili, subisce nel corso dei secoli vari rimaneggiamenti. Il Barocco siciliano s'innesta con arricchimenti tipici della cultura decorativa dell'epoca.

In relazione ai restauri il più poderoso e invasivo è effettuato alla fine del Settecento, quando in occasione del consolidamento strutturale si rimodella radicalmente l'interno su progetto di Ferdinando Fuga.
I lavori hanno inizio nel 1781, eseguiti non dal Fuga ma dal palermitano Carlo Chenchi con l'assistenza di Giuseppe Venanzio Marvuglia e durano fino ai primi anni del XIX secolo. Il restauro complessivo comporta un allargamento sui fianchi con la trasformazione delle cappelle laterali sulle navate laterali e le nuove cappelle costruite di sana pianta, il Portico meridionale avanzato di parecchi metri e interamente riassemblato per anastilosi a cura del capomastro Francesco Patricolo. Rimodulazione della facciata nord. Questo ed altri rifacimenti realizzati in seguito al terremoto del 1823, hanno reso la Cattedrale quello che è oggi; la più alta rappresentazione dell'arte e della storia di Palermo.
Duomo di Monreale
Continuando a percorrere l'Itinerario Arabo Normanno, non si può non citare il Duomo di Monreale.
La Chiesa fu voluta nel 1174 da Guglielmo II; era detto il buono e viene ricordato come uno dei monarchi normanni che ebbe la maggiore benevolenza popolare.
Dante nella sua "Commedia" lo nomina nel XX canto del Paradiso in questi termini:
«E quel che vedi ne l'arco declivo,
Guglielmo fu, cui quella terra plora
che piagne Carlo e Federigo vivo:
ora conosce come s'innamora
lo ciel del giusto rege, e al sembiante
del suo fulgore il fa vedere ancora.»
La nascita del Duomo è avvolta dalla leggenda, secondo il mito, Guglielmo, succeduto al padre sul trono di Sicilia, si sarebbe addormentato sotto un carrubo, colto da stanchezza, mentre era a caccia nei boschi di Monreale. In sogno gli apparve la Madonna, a cui era molto devoto, che gli rivelò il segreto di una “truvatura” con queste parole: “Nel luogo dove stai dormendo è nascosto il più grande tesoro del mondo: dissotterralo e costruisci un tempio in mio onore”. Dette queste parole, la Vergine scomparve e Guglielmo, fiducioso della rivelazione in sogno, ordinò che si sradicasse il carrubo e gli si scavasse intorno. Con grande stupore venne scoperto un tesoro in monete d'oro che furono subito destinate alla costruzione del Duomo di Monreale.
I suoi contemporanei plaudono alla costruzione di una meraviglia architettonica motivata da sinceri e profondi intendimenti religiosi, attribuendone senza tema di smentita, il finanziamento agli enormi proventi e tesori raccolti da un re avarissimo e depredatore qual era stato Guglielmo il Cattivo, considerato un rapace e razziatore delle ricchezze del suo regno.
Altre considerazioni ruotano attorno le vicende circa le competizioni tra i cantieri dei grandi poli monumentali nella città di Palermo e immediate vicinanze. Guglielmo è promotore e patrocinatore dell'edificazione di tutto il complesso benedettino di Monreale, al tempo stesso come sovrano, appoggia e sostiene il vescovo Gualtiero Offamilio nella ricostruzione della cattedrale di Palermo. Per i due, le imprese costituirono vere e proprie sfide di grandezza e autocelebrazione, ognuna di esse condotta con l'obiettivo di surclassare in potenza ed eccellenza il proprio avversario.
Guglielmo il buono si concentrò più sull'abbellimento dell'aspetto interno del duomo, dotandolo di mosaico dorato, poiché lo accostava all'animo dell'essere umano, come aspetto fondamentale dell'essere piuttosto che l'aspetto esteriore. Al contrario l'arcivescovo curò maggiormente l'aspetto esterno della cattedrale di Palermo, poiché per lui la bellezza esteriore era quella che colpiva di più l'attenzione delle persone.
Il primo favorì la diffusione del messaggio evangelico tra i ceti meno abbienti attraverso i preziosi cicli figurati tratti dalle Sacre Scritture, il secondo esaltò la potenza dello spirito mediante le ardite strutture architettoniche. A termine dei lavori entrambi visitarono la cattedrale edificata dal concorrente, constatando quello che mancava alla propria che l'altro aveva posto in essere.
La cattedrale di Santa Maria Nuova si trova nel centro storico di Monreale, adagiato sulle pendici del monte Caputo.
L'edificio segue il modello delle grandi basiliche benedettine di provenienza cluniacense. La facciata, prospiciente una piazza quadrangolare, è stretta fra le due torri campanarie, delle quali quella di sinistra rimasta incompiuta al primo ordine. L'ingresso è preceduto dal portico settecentesco, in stile barocco, che si apre sull'esterno con tre archi a tutto sesto poggianti su colonne tuscaniche; al di sotto di esso, vi è il portale, chiuso da due battenti bronzei, opera di Bonanno Pisano e risalenti al 1185 - 1186. Nella parte superiore della facciata, terminante con un basso timpano triangolare, si apre una monofora ogivale incorniciata da una decorazione ad archetti ciechi intrecciati fra di loro. Caratteristica peculiare dell'arte scultorea e architettonica normanna di Sicilia è il baton brises elementi scultorei architettonici a zig-zag di origine anglo-normanna presenti nella cattedrale di Monreale e ampiamente utilizzati in Inghilterra e in Sicilia sia in età normanna che in seguito.
L'esterno, modificato nei secoli XVI e XVIII, nell'area absidale conserva intatta l'impronta normanna ed è ornato a vari disegni formanti una serie di archi di pietre bianche e nere con cerchi al di sotto, assai ben combinati e disposti tra loro. La decorazione delle tre absidi, caratterizzata dal fitto intreccio di archi acuti, evoca atmosfere arabeggianti esaltate dalla decorazione policroma creata dall'alternanza di tarsie di calcare e di pietra lavica.
Il vasto interno della cattedrale ha pianta a croce latina con transetto poco sporgente che di fatto è una
continuazione ai lati del presbiterio delle navate laterali. Le navate, terminante ciascuna con un'abside semicircolare, sono divise da colonne antiche con pulvino e capitelli anch'essi antichi con clipei di divinità che sostengono archi a sesto acuto di tipo arabo. I soffitti sono a travature scoperte dipinti nelle navate e a stalattiti di tipo arabo nella crociera, questi ultimi rifatti nel 1811 dopo un incendio che aveva distrutto parte del tetto. Il pavimento, completato nel XVI secolo è musivo, con dischi di porfido e granito e con fasce marmoree intrecciate a linee spezzate.
All'interno è poi possibile osservare sul fianco destro dell'abside il sarcofago in porfido di Guglielmo I, morto nel 1166, e quello marmoreo di Guglielmo II. Sul lato sinistro, dentro tombe ottocentesche, si trovano invece le spoglie di Margherita di Navarra e di Sicilia, moglie di Guglielmo I, e dei figli Ruggero ed Enrico e la Cappella di San Luigi dei Francesi con i resti del re Luigi IX.
La parte più bassa delle pareti, dal fregio “a palmizi” al piano pavimentale, sul modello della Cappella Palatina di Palermo, è uniformemente resa ad incrostazione marmorea e fasce verticali (in tutto 493 unità), in mosaico ruotato, a motivi geometrici. Tali opere, assieme al pavimento del grande presbiterio e agli intarsi sugli arredi marmorei e sulle membrature architettoniche, costituiscono un complesso esecutivo di consistente estensione (circa 300 m² per le fasce a parete, e 975 m² per il pavimento del grande presbiterio) e un repertorio di motivi decorativi straordinariamente vario e numeroso. La cronologia esecutiva copre un arco temporale che va dalle origini della costruzione normanna fino ai primi anni del secolo scorso, con un incremento di intensità operativa nel corso dell'Ottocento, durante il quale si attuarono consistenti ed estesi interventi di restauro e integrazione. In attesa che giunga a compimento il lavoro di studio del prof. Giuseppe Oddo, sul mosaico decorativo in opus sectile a motivi geometrici del duomo di Monreale non sussiste al momento uno studio complessivo e organico.
Duomo di Cefalù
Cari amici, continua il nostro Itinerario Arabo-Normanno; oggi "visiteremo" la Cattedrale di Cefalù.
Costruito nel 1131 per volontà del normanno Ruggero ll, primo Re di Sicilia, il Monumento deve il suo splendore alla fusione di elementi diversi: la genialità e l’originalità degli architetti e delle maestranze islamiche, la raffinatezza bizantina nell’arte della pittura e del mosaico, l’influenza della cultura e dell'architettura normanne.
Significative le pitture del soffitto che rappresentano il paradiso islamico (1148).
La Cattedrale fu concepita anche come mausoleo di Ruggero ma il lento processo di decadimento che l’edificio subì dopo la sua morte convinse Federico Il, nel 1215, a trasferire a Palermo il sarcofago porfireo del Re normanno.
Alcuni anni dopo, nel 1240, ebbe inizio il restauro che comportò notevoli modifiche, anche stilistiche, del tempio originario come, tra le più evidenti, l’abbassamento del soffitto ligneo della navata principale, che oggi si presenta a capriate, e la parziale rotazione del transetto.
Il sagrato della Cattedrale, antico cimitero pubblico, è stato realizzato con la terra “santa" portata da Gerusalemme. La facciata è opera dell’architetto Panittera (1240) e il bel portico di Ambrogio da Como (1473).
 All’interno, si rimane sopraffatti dal solenne mosaico di fattura bizantina che domina il catino dell’abside raffigurante Cristo Pantocratore, su fondo oro che benedice con le sole tre dita della mano destra, secondo il rito greco.
All’interno, si rimane sopraffatti dal solenne mosaico di fattura bizantina che domina il catino dell’abside raffigurante Cristo Pantocratore, su fondo oro che benedice con le sole tre dita della mano destra, secondo il rito greco.
I mosaici ricoprono anche le pareti del presbiterio e la volta. Rappresentazioni di Patriarchi, Profeti, Santi. Angeli, Arcangeli, della Vergine e dei dodici Apostoli impreziosiscono le altre pareti e le vele delle volte.
Alla magnificenza dei decori ed allo sfavillio delle tessere dei mosaici si contrappone l’austero pavimento in pietra grigia. Nell’abside è degna di ammirazione la grande croce lignea bifronte dipinta nel xv secolo da Guglielmo da Pesaro.
Pregevoli il fonte battesimale romanico nella navata destra, gli stucchi barocchi (1650) nella navata centrale di Scipioni Livolsi con pitture di Ignazio
Bongiovanni ed una Madonna con Bambino attribuita ad Antonello Gagini, vicino all'ingresso nella navata sinistra.
Le due navate laterali sono costellate di sepolcri, pregevoli monumenti funebri di nobili (in particolare i sarcofagi della famiglia Ventimiglia) ed ecclesiastici: si segnala. in fondo alla navata destra, il sarcofago che custodisce le spoglie di Eufemia di Aragona, sorella di Federico (morta a Cefalù il 28 febbraio 1359), in chiaro stile paleocristiana. Lungo il lato sinistro del transetto si può ammirare la Cappella del Sacramento, voluta da monsignor Castelli ornata interamente in argento.
L’altare ( 1764-1779 ) è frutto del sapiente lavoro degli argentieri palermitani Gregorio Balsamo, Giovanni Rossi e Giuseppe Russo.
Sulla parete di fronte alla Cappella sono degni di nota il monumento del vescovo Giovanni Sergio ( 1814-1827) in atteggiamento di adorazione, opera di Leonardo Pennino, e un affresco raffigurante la Vergine risalente al XIV secolo. Ma la vera protagonista, all’interno di questo splendido tempio della cristianità, è la luce che, filtrando attraverso le 32 vetrate, diffonde una magica atmosfera.
Le vetrate, in stile astratto, sono state realizzate dall'artista palermitano Michele Canzonieri.
Chiesa della Martorana
Altro importante sito testimone dell'arte Arabo-Normanna, anch'esso facente parte del percorso tutelato dall'Unesco, è di Santa Maria dell'ammiraglio: la Martorana.
La chiesa è situata nel centro storico di Palermo; essa appartiene all'eparchia
di Piana degli Albanesi, circoscrizione della Chiesa italo-albanese, e officia
la liturgia per gli italo-albanesi residenti in città secondo il rito bizantino.
Edificio bizantino del Medioevo, è testimonianza della
cultura religiosa e artistica orientale presente ancora oggi in Italia,
ulteriormente apportata dagli esuli albanesi rifugiatisi in Sicilia sotto
l'incalzare delle persecuzioni turche nei Balcani. Quest'ultimo influsso ha
lasciato notevoli tracce nella pittura delle icone, nel rito religioso, nella
lingua, nei costumi tradizionali proprie di alcune colonie albanesi nella
provincia di Palermo. La comunità è parte della Chiesa cattolica, ma segue il
rito e le tradizioni spirituali che l'accomunano in gran parte alla Chiesa
ortodossa.
Si contraddistingue per la molteplicità di stili che
s'incontrano, in quanto, con il susseguirsi dei secoli, fu arricchita da vari
altri gusti artistici, architettonici e culturali. Oggi si presenta, infatti,
come chiesa-monumento storico, frutto delle molteplici trasformazioni,
sottoposta inoltre a tutela.
La chiesa fu fondata nel 1143 per volere di Giorgio
d'Antiochia, grande ammiraglio siriaco di fede ortodossa al servizio del re
normanno Ruggero II dal 1108 al 1151. Costruita da artisti orientali secondo il
gusto bizantino, si trovava nei pressi del vicino monastero benedettino,
fondato dalla nobildonna Eloisa Martorana nel 1194, motivo per il quale diventò
nota successivamente come "Santa Maria dell'Ammiraglio" o della
"Martorana" (precedentemente Giorgio l'Antiocheno fece edificare
anche il possente "Ponte Ammiraglio" sul fiume Oreto, noto anche per
una battaglia dei garibaldini). All'edificio sacro, che nel corso dei secoli è
stato più volte distrutto e restaurato, si accede dal campanile: una
costruzione a pianta quadrata del XIII secolo, aperta in basso da arcate a
colonne angolari e con tre ordini di grandi bifore.
La chiesa possiede una pianta a croce greca, prolungata con
il nartece e l'atrio. Un portale assiale (ancora esistente) da sull'atrio e il
nartece, come nelle prime chiese cristiane. Al di là del nartece, l'edificio
era sistemato e decorato come una chiesa bizantina a 4 colonne, tranne gli
archi a sesto acuto e i pennacchi della cupola che erano di gusto islamico. Nel
1193 le case attorno vengono adibite a monastero per le donne e la chiesa verrà
poi ad esso inglobata.
Nel 1394 c. fu fondato il monastero attiguo, patrocinato dai
coniugi Goffredo e Luisa Martorana, da cui prenderà successivamente il nome. Il
7 dicembre 1433, col privilegio concesso da Alfonso V d'Aragona e confermato da
Papa Eugenio IV, la chiesa dell'Ammiraglio è assegnata al monastero adiacente.
Essendo l'edificio compreso nel recinto della clausura, le monache utilizzano
la nuova struttura più prestigiosa, abbandonando il luogo di culto proprio del
monastero, passando al rito latino.
 L'ambiente interno corrisponde al rifacimento settecentesco con volte affrescate da Olivio
Sozzi, Antonio Grano e Guglielmo Borremans, due decorazioni musive sul fronte
del corpo originario raffigurano uno Ruggero II vestito da imperatore bizantino
e incoronato re per mano di Gesù Cristo; l'altro la dedicazione della chiesa
alla Vergine da parte dell'ammiraglio d'oriente Giorgio d'Antiochia,
quest'ultimo rappresentato in umile atto di prostrazione dinanzi alla Madonna.
Sulla parete occidentale dello stesso locale è murata una lapide che ricorda
l'eroe nazionale degli albanesi con l'incisione dell'aquila bicipite
costantinopolitana, simbolo degli albanesi. Ai lati icone bizantine della
committenza arbëreshe abbelliscono la chiesa. Superato l'ambiente suddetto, si
giunge nella chiesa medievale, il nucleo originale. Qui la parte superiore
delle pareti e la cupola, al sommo della quale si erge l'immagine del Cristo
Pantocratore, sono interamente rivestite da decorazioni musive bizantine di
grande importanza, in connessione con quelle riguardanti Dafne nell'Attica. Il
grandioso ciclo di mosaici bizantini della chiesa è il più antico di Sicilia. I
mosaici della cupola rappresentano al centro il Cristo, scendendo
successivamente i quattro arcangeli (tre originali più uno apocrifo) e i
patriarchi, mentre nelle nicchie sono ospitati i quattro evangelisti e infine,
nelle volte, i rimanenti apostoli.
L'ambiente interno corrisponde al rifacimento settecentesco con volte affrescate da Olivio
Sozzi, Antonio Grano e Guglielmo Borremans, due decorazioni musive sul fronte
del corpo originario raffigurano uno Ruggero II vestito da imperatore bizantino
e incoronato re per mano di Gesù Cristo; l'altro la dedicazione della chiesa
alla Vergine da parte dell'ammiraglio d'oriente Giorgio d'Antiochia,
quest'ultimo rappresentato in umile atto di prostrazione dinanzi alla Madonna.
Sulla parete occidentale dello stesso locale è murata una lapide che ricorda
l'eroe nazionale degli albanesi con l'incisione dell'aquila bicipite
costantinopolitana, simbolo degli albanesi. Ai lati icone bizantine della
committenza arbëreshe abbelliscono la chiesa. Superato l'ambiente suddetto, si
giunge nella chiesa medievale, il nucleo originale. Qui la parte superiore
delle pareti e la cupola, al sommo della quale si erge l'immagine del Cristo
Pantocratore, sono interamente rivestite da decorazioni musive bizantine di
grande importanza, in connessione con quelle riguardanti Dafne nell'Attica. Il
grandioso ciclo di mosaici bizantini della chiesa è il più antico di Sicilia. I
mosaici della cupola rappresentano al centro il Cristo, scendendo
successivamente i quattro arcangeli (tre originali più uno apocrifo) e i
patriarchi, mentre nelle nicchie sono ospitati i quattro evangelisti e infine,
nelle volte, i rimanenti apostoli.
La chiesa è fornita di un'antica iconostasi in marmi mischi,
in cui, essendo priva di icone, i papàdes albanesi dell'epoca hanno provvisto
la realizzazione dei mosaici della Madonna, del Cristo e dalle icone di Maria
Vergine e San Nicola di Mira, questi ultimi che precedono l'iconostasi. Molto
importante per i fedeli arbëreshë è la grande icona raffigurante San Nicolò in
trono (XV sec.), posta oggi nel diaconicon e che si trovava nella chiesa di San
Nicolò dei Greci che, unitamente al contiguo Seminario Italo-Albanese di
Palermo, andò distrutta nel bombardamento aereo del 1943. L'abside, abbattuta
sul finire del Seicento, venne sostituita con l'attuale cappella barocca a
tarsie marmoree su progetto di Paolo Amato. Icone contemporanee, alcune delle
quali dell'iconografo italo-albanese Zef Giuseppe Barone da Piana degli
Albanesi (croce bizantina della morte e resurrezione del Cristo, dipinta in
entrambi i lati) e altri realizzate dell'iconografo e mosaicista albanese Josif
Droboniku (raffiguranti le dodici feste despotiche e la grande crocifissione
dell'altare bizantino), appartengono all'importante patrimonio artistico della
parrocchia.
San Giovanni degli Eremiti
Continuiamo il nostro viaggio nell’arte Arabo-Normanna visitando
la Chiesa di San Giovanni degli Eremiti.
Chiesa e convento di S. Giovanni degli Eremiti, secondo le
cronache, furono edificati per volere del primo re di Sicilia Ruggero II,
sovrano illuminato e colto, tra il 1132 e il 1148 su più antiche preesistenze
di epoche diverse e affidati ai padri benedettini di Montevergine.
Lo storico Rocco Pirri nel suo “Sicilia Sacra”, mette in
relazione il sito con uno dei monasteri benedettini fondati nel VI secolo da
San Gregorio Magno nei possedimenti siciliani della propria madre, quello di S.
Ermete (da qui l’etimo “Eremiti”).
Nei secoli sembra che questo luogo abbia mantenuto sempre
una destinazione religiosa, infatti, durante il dominio musulmano dell’isola,
vi sorgeva presumibilmente, una moschea araba.
La vicinanza del monastero con la residenza regia ne fece
subito luogo privilegiato, destinato anche alla sepoltura degli alti dignitari
della corte normanna: il suo abate, che era anche il confessore privato del re,
godeva del titolo di primo cappellano della cappella reale e di numerosi
privilegi. Dopo un lungo periodo di abbandono, nel 1464 il complesso monastico
(ormai privo di religiosi) fu assegnato da papa Paolo II, su suggerimento del
cardinale Giovan Nicolò Ursino, ai monaci benedettini di San Martino delle
Scale e poi, nel 1524 per volontà dell’imperatore Carlo V, fu concesso come
“Gancìa” (ospizio) ai monaci benedettini di Monreale e all’arcivescovo di
quella diocesi per la propria abitazione (in questa occasione l’intero
complesso venne profondamente trasformato).
Le costruzioni normanne (chiesa e monastero), sono state
edificate (come altre costruzioni del periodo), secondo modelli architettonici
marcatamente islamici (architetti e maestranze erano di origini musulmane),
frutto di una mediazione tra culture artistiche diverse, quella orientale e
quella cristiana, che permise l’evolversi di un’arte e di un’architettura
davvero unica nel suo genere.
La chiesa di S. Giovanni degli Eremiti, che nel corso dei
secoli ha subito varie modifiche e trasformazioni, ha una struttura a forma di
parallelepipedo, con proporzioni armoniose e non troppo grandi.
 La sua architettura, è fondata essenzialmente sul rigore
geometrico, i paramenti murari sono costituiti da strati di piccoli conci di
La sua architettura, è fondata essenzialmente sul rigore
geometrico, i paramenti murari sono costituiti da strati di piccoli conci di
L’interno, di forma geometrica semplice, si presenta
spoglio, assai severo e disadorno di ogni decorazione con una disposizione
planimetrica a croce commissa, cioè a forma di una T che si ripete per ben
cinque volte: nelle due grandi campate dell’unica navata e con dimensioni più
ridotte, sul vano che precede l’abside maggiore, nel diaconico e infine, a
nord, sulla caratteristica torre campanaria.
La navata è composta da due ampie campate quadrate separate
da un possente arco ogivale e si conclude con un transetto triabsidato la cui
abside centrale, pressoché semicircolare, è pronunciata all’esterno oltre la
struttura del muro: due soli archi ogivali traversi intervallano lo spazio
longitudinale della navata.
Eremiti. Un ruolo determinante è rivestito dalla luce che
penetra all’interno della chiesa, infatti per la sua particolare conformazione
riesce a calibrare effetti di luce e ombre senza ricorrere ad espedienti
scultorei o pittorici, o decorazioni musive, affidandosi soprattutto ad un uso
sapiente delle aperture ogivali, che originariamente erano coperte da transenne
preziosamente traforate in gesso, che un tempo schermavano le finestre.
Quello che resta oggi dell’antico monastero benedettino è
l’elegante “chiostro”, costruito successivamente, in una data imprecisata, ma
che per caratteristiche costruttive e stilistiche sembra probabilmente essere
stato costruito intorno alla fine del XIII secolo.
Di forma rettangolare oggi è ridotto quasi allo stato di
rudere, vi si possono ancora ammirare i resti di mura perimetrali e un’agile
fuga di colonnine binate (simili a quelle del chiostro di Monreale) con arcate
gotiche a sesto acuto.
Vi si accede attraverso un lussureggiante giardino
ottocentesco di tipo mediterraneo (una piccola oasi di pace) connotato da una
rigogliosa flora in prevalenza fatta da piante esotiche, composta da varie
tipologie di palme, agrumi di vari generi, allori, ulivi, nespoli, agavi; tutta
questa vegetazione e gli scorci della chiesa, inquadrati dagli archetti gotici,
conferiscono al luogo un fascino particolare.
 Il piano terra del palazzo è costituito da un lungo
vestibolo interno che corre per tutta la lunghezza della facciata principale
sul quale si aprono al centro la grande Sala della Fontana, nella quale il
sovrano riceveva la corte, e ai lati una serie di ambienti di servizio con le
due scale d'accesso ai piani superiori. La Sala della Fontana, di gran lunga
l'elemento architettonico più caratterizzante dell'intero edificio, ha una
pianta quadrata sormontata da una volta a crociera ogivale, con tre grandi
nicchie su ciascuno dei lati della stanza, occupate in alto da semicupole
decorate da muqarnas (decorazioni ad alveare). Nella nicchia sull'asse
dell'ingresso principale si trova la fontana sormontata da un pannello a
mosaico su fondo oro, sotto il quale scaturisce l'acqua che, scivolando su una
lastra marmorea decorata a chevrons posta in posizione obliqua, viene
canalizzata in una canaletta che taglia al centro il pavimento della stanza e
che arriva alla peschiera antistante. In questo ambiente sono ancora visibili i
resti di affreschi parietali realizzati nel Seicento dai Sandoval.
Il piano terra del palazzo è costituito da un lungo
vestibolo interno che corre per tutta la lunghezza della facciata principale
sul quale si aprono al centro la grande Sala della Fontana, nella quale il
sovrano riceveva la corte, e ai lati una serie di ambienti di servizio con le
due scale d'accesso ai piani superiori. La Sala della Fontana, di gran lunga
l'elemento architettonico più caratterizzante dell'intero edificio, ha una
pianta quadrata sormontata da una volta a crociera ogivale, con tre grandi
nicchie su ciascuno dei lati della stanza, occupate in alto da semicupole
decorate da muqarnas (decorazioni ad alveare). Nella nicchia sull'asse
dell'ingresso principale si trova la fontana sormontata da un pannello a
mosaico su fondo oro, sotto il quale scaturisce l'acqua che, scivolando su una
lastra marmorea decorata a chevrons posta in posizione obliqua, viene
canalizzata in una canaletta che taglia al centro il pavimento della stanza e
che arriva alla peschiera antistante. In questo ambiente sono ancora visibili i
resti di affreschi parietali realizzati nel Seicento dai Sandoval.
La Zisa
Il palazzo della Zisa (dall'arabo al-ʿAzīza, ovvero "la
splendida") sorgeva fuori le mura della città di Palermo, all'interno del
parco reale normanno, il Genoardo (dall'arabo Jannat al-arḍ ovvero
"giardino" o "paradiso della terra"), che si estendeva con
splendidi padiglioni, rigogliosi giardini e bacini d'acqua da Altofonte fino
alle mura del palazzo reale.
L’imponente dimora, un autentico gioiello di architettura
islamica, fu eretta per volontà di Guglielmo I detto “il Malo”, il quale,
ambiziosamente suggestionato dal fascino della regalità, voleva una reggia che
superasse per comodità e perfezione artistica quelle edificate dal padre
Ruggero II.
L’opera fu completata dal figlio Guglielmo II, come è
testimoniato dall’iscrizione in caratteri “nàskhi“ nell’arco d’ingresso della
Sala della Fontana nella quale si esalta il palazzo e colui che lo ha ultimato,
chiamato con l’appellativo “Musta’izz” (bramoso di gloria), di cui si fregiava
quest’ultimo sovrano.
Il palazzo della zisa, concepito come dimora estiva dei re,
rappresenta uno dei migliori esempi del connubio di arte e architettura
normanna con ambienti tipici della casa normanna(compresa la doppia torre
cuspidata) e decorazioni e ingegnerie arabe per il ricambio d'aria negli
ambianti. Si tratta, infatti, di un edificio rivolto a nord-est, cioè verso il
mare per meglio godere delle brezze più temperate, specialmente notturne, che
venivano captate dentro il palazzo attraverso i tre grandi fornici della
facciata e la grande finestra belvedere del piano alto. Questi venti, inoltre,
venivano inumiditi dal passaggio sopra la grande peschiera antistante il
palazzo e la presenza di acqua corrente all'interno della Sala della Fontana
dava una grande sensazione di frescura. L'ubicazione del bacino davanti al
fornice d'accesso, infatti, è tutt'altro che casuale: esso costituiva una fonte
d'umidità al servizio del palazzo e le sue dimensioni erano perfettamente calibrate
rispetto a quelle della Zisa. Anche la dislocazione interna degli ambienti era
stata condizionata da un sistema abbastanza complesso di circolazione dell'aria
che attraverso canne di ventilazione, finestre esterne ed altri posti in
riscontro stabilivano un flusso continuo di aria.
La stereometria e la simmetria del palazzo sono assolute.
Esso è orizzontalmente distribuito in tre ordini, il primo dei quali al piano
terra è completamente chiuso all'esterno, fatta eccezione per i tre grandi
fornici d'accesso. Il secondo ordine è segnato da una cornice marcapiano che
delinea anche i vani delle finestre, mentre il terzo, quello più alto, presenta
una serie continua di arcate cieche. Una cornice con l'iscrizione dedicatoria
chiudeva in alto la costruzione con una linea continua. Si tratta di
un'iscrizione in caratteri cufici, molto lacunosa e priva del nome del re e
della data, che è tuttora visibile nel muretto d'attico del palazzo. Questa
iscrizione venne, infatti, tagliata ad intervalli regolari per ricavarne merli
nel momento in cui il palazzo fu trasformato in fortezza.
 Il piano terra del palazzo è costituito da un lungo
vestibolo interno che corre per tutta la lunghezza della facciata principale
sul quale si aprono al centro la grande Sala della Fontana, nella quale il
sovrano riceveva la corte, e ai lati una serie di ambienti di servizio con le
due scale d'accesso ai piani superiori. La Sala della Fontana, di gran lunga
l'elemento architettonico più caratterizzante dell'intero edificio, ha una
pianta quadrata sormontata da una volta a crociera ogivale, con tre grandi
nicchie su ciascuno dei lati della stanza, occupate in alto da semicupole
decorate da muqarnas (decorazioni ad alveare). Nella nicchia sull'asse
dell'ingresso principale si trova la fontana sormontata da un pannello a
mosaico su fondo oro, sotto il quale scaturisce l'acqua che, scivolando su una
lastra marmorea decorata a chevrons posta in posizione obliqua, viene
canalizzata in una canaletta che taglia al centro il pavimento della stanza e
che arriva alla peschiera antistante. In questo ambiente sono ancora visibili i
resti di affreschi parietali realizzati nel Seicento dai Sandoval.
Il piano terra del palazzo è costituito da un lungo
vestibolo interno che corre per tutta la lunghezza della facciata principale
sul quale si aprono al centro la grande Sala della Fontana, nella quale il
sovrano riceveva la corte, e ai lati una serie di ambienti di servizio con le
due scale d'accesso ai piani superiori. La Sala della Fontana, di gran lunga
l'elemento architettonico più caratterizzante dell'intero edificio, ha una
pianta quadrata sormontata da una volta a crociera ogivale, con tre grandi
nicchie su ciascuno dei lati della stanza, occupate in alto da semicupole
decorate da muqarnas (decorazioni ad alveare). Nella nicchia sull'asse
dell'ingresso principale si trova la fontana sormontata da un pannello a
mosaico su fondo oro, sotto il quale scaturisce l'acqua che, scivolando su una
lastra marmorea decorata a chevrons posta in posizione obliqua, viene
canalizzata in una canaletta che taglia al centro il pavimento della stanza e
che arriva alla peschiera antistante. In questo ambiente sono ancora visibili i
resti di affreschi parietali realizzati nel Seicento dai Sandoval.
Il primo piano si presenta di dimensioni più piccole, poiché
buona parte della sua superficie è occupata dalla Sala della Fontana e dal
vestibolo d'ingresso, che con la loro altezza raggiungono il livello del piano
superiore. Esso è costituito a destra e a sinistra della Sala della Fontana
dalle due scale d'accesso che si aprono su due vestiboli. Questi si affacciano
con delle piccole finestre sulla parte alta della Sala, affinché, anche dal
piano superiore, si potesse osservare quanto accadeva nel salone di
ricevimento. Questo piano costituiva una delle zone residenziali del palazzo ed
era destinato molto probabilmente alle donne.
Il secondo piano constava originariamente di un grande atrio
centrale delle stesse dimensioni della sottostante Sala della Fontana, di una
contigua sala belvedere che si affaccia sul prospetto principale e di due unità
residenziali poste simmetricamente ai lati dell'atrio. Questo piano dovette
certamente assolvere alla funzione di luogo di soggiorno estivo privato, dal
momento che l'atrio centrale scoperto apriva questo luogo all'aria ed alla
luce.
Facevano parte del complesso monumentale normanno anche un
edificio termale, i cui resti furono scoperti ad ovest della residenza
principale durante i lavori di restauro del palazzo, ed una cappella palatina
posta poco più ad ovest, lungo la via oggi nominata dei Normanni. Costruita nel
XII secolo, la Cappella Palatina della Santissima Trinità presso il Palazzo
della Zisa è documentata già sotto il regno di Guglielmo II di Sicilia come
Cappella Palatina della residenza. È utilizzata come sacrestia della Chiesa di
Gesù, Maria e Santo Stefano alla Zisa, appartiene alla parrocchia della Chiesa
dell'Annunziata.














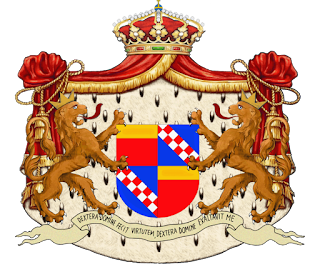

Commenti
Posta un commento