Palazzo Belmonte Riso
Cari amici, oggi vi porto alla scoperta dell'antico palazzo nobiliare dei Ventimiglia, l'attuale Palazzo Belmonte Riso sede del museo d'arte contemporanea.
La storia del Palazzo dei Ventimiglia di Belmonte, inizia
nel XVIII secolo quando venne completamente riprogettato dall’architetto
Giuseppe Venazio Marvuglia per volere di Emanuele Ventimiglia, principe di
Belmonte, in seguito all’acquisizione di fabbricati limitrofi alla residenza
nobiliare di origine cinquecentesca appartenente alla famiglia Afflitto.
La stessa che sorgeva sull’attuale area di Palazzo Riso
venne completamente demolita con lo scopo di realizzare una nuova e più ampia
dimora nobiliare per il principe, estendendosi fino i limiti dei nuovi edifici acquistati.
Nacque così un nuovo palazzo a pianta rettangolare e di tre piani fuori terra
impostato lungo due corti coassiali, espressione della magnificenza
tardo-barocca e rigore neoclassico.
La continua stratificazione di soglie storiche è
caratteristica intrinseca di Palazzo Riso, nonché dell’insula di Belmonte,
nonché dell’intero centro storico di Palermo e rappresenta un tema fondamentale
del progetto di tesi di ampliamento del Museo Riso.
Palazzo Belmonte Riso si trova nel centro storico di Palermo
nell’area del Cassaro alto che costituisce il nucleo più antico della città.
Questo nucleo orograficamente definito a nord e a sud dagli antichi alvei dei fiumi
Papireto e Kemonia è visibile tutt’ora dalla presenza di notevoli salti di
quota.
Il fronte principale di Palazzo Belmonte Riso si affaccia direttamente
sul Cassaro, oggi via Vittorio Emanuele II. La strada venne tracciata con la
creazione stessa della città da parte dei Fenici, e tagliava in due parti l’agglomerato
collegando l’originario porto, l’antica Paleapoli alla Neapoli posta subito alle
spalle della città. Questa strada diventerà con il consolidarsi della struttura
urbana l’asse portante che fino al XVI secolo caratterizzerà gli sviluppi
urbanistici di Palermo. Il suo nome ha origine araba, deriva dalla parola al Qasr
che significa “fortificato”.
Come frequentemente accade per le dimore nobiliari che
spesso si compongono per successive addizioni di lotti adiacenti anche la
storia di Palazzo Belmonte Riso è strettamente collegata alle sorti di tutto il
suo intorno.
Sebbene la nascita effettiva dello stesso avvenne solo nella
seconda metà del XVIII secolo, è bene approfondire le vicende che già nei
secoli precedenti interessarono l’area del Palazzo.
Nel 1416, venne registrata la cessione di un vasto complesso
edilizio della contrada di San Biagio da parte della famiglia Filangeri alle
famiglie Afflitto e Calvello. Fu Pietro Afflitto ad acquistare da Isolada
Filangeri un hospicium magnum, situato lungo il Cassaro tra la contrada San
Biagio e la Vanella del Cancelliere, comprensivo di teatri, cortili e botteghe, tutto in rovina.
Intorno al 1428 Pietro Afflitto integra gli edifici prospicienti il Cassaro, ad
angolo col vicolo del Cancelliere, componendoli in forma palaziale con un piano
terreno, un primo piano con finestre e con una torre.
Nell’intervallo compreso tra il 1424 e il 1482 si attesta la
ricostruzione dell’antica chiesa di San Biagio che verrà distrutta circa un
secolo dopo, nel 1526 per volere della famiglia Balsamo con l’intento di
costruirne un’altra più grande sulla piazza del Cancelliere, per fare posto a
quello che sarà il palazzo Ventimiglia di Geraci.
Il 2 settembre 1527, Elisabetta Morso, vedova di Vincenzo
Afflitto ottiene l’elevazione feudale di un fondo allodiale detto “Mezzagno”,
situato a sud-est di Palermo e la conseguente concessione del relativo titolo di
Principe di Belmonte.
Il 12 luglio 1567, venne deliberato dal Senato cittadino
l’allargamento della strada del Cassaro.
Probabilmente le famiglie palermitane più influenti del
tempo, quali gli Afflitto, i Castrone e i Beccadelli Bologna, le cui residenze
si attestavano lungo l’asse, influiscono su questa scelta, così da conferire
una maggiore visibilità ed importanza ai loro palazzi. A conferma
dell’importanza della famiglia Afflitto e della loro residenza, durante i lavori
sul Cassaro, la facciata non viene intaccata.
Nel 1661 si registra il passaggio di proprietà del palazzo
dagli Afflitto ai Ventimiglia, in seguito al matrimonio tra Ninfa Afflitto con
Francesco Ventimiglia.
 Nel 1725, con la trasmissione del palazzo a Giuseppe Emanuele III Ventimiglia, principe e fondatore di Belmonte Mezzagno, inizia la vera rifondazione
architettonica di tutto il futuro complesso palaziale.
Nel 1725, con la trasmissione del palazzo a Giuseppe Emanuele III Ventimiglia, principe e fondatore di Belmonte Mezzagno, inizia la vera rifondazione
architettonica di tutto il futuro complesso palaziale.
Nel 1728, probabilmente, l’architetto Ferdinando Fuga
partecipa ai lavori resi necessari dal terremoto che nel 1726 colpì la città di
Palermo. Durante questa fase il principe avvia l’acquisizione di fabbricati
limitrofi per la realizzazione di un nuovo palazzo. Così nel 1760 avviene la
transizione tra il Principe di Belmonte e il marchese Geraci per sancire tutte
le servitù che si sarebbero create con la nuova realizzazione del palazzo.
Per il progetto di ricostruzione venne eseguito un modello
ligneo, avvalendosi degli architetti Nicolò Palma e Giovanni del Frago. Sarà
poi Giuseppe Venazio Marvuglia a proseguire i lavori al palazzo che saranno ultimati
nel 1784.
Nel 1834 in seguito alla morte di Giuseppe Emanuele
Ventimiglia, il palazzo viene trasmesso in eredità alla nipote Marianna, moglie
del Principe di Pandolfina. Nel 1841, il figlio di Marianna, Ferdinando Monroy,
vende il palazzo a Pietro Riso, barone di Colobria. Il passaggio di proprietà è
suggellato nello stemma del palazzo: allo scudo dei Ventimiglia viene infatti aggiunto
un braccio con una mano che regge un mazzo di spighe, emblema dei nuovi
proprietari.
Aldilà delle modificazioni che interesseranno Palazzo Riso
dal XVIII secolo sino ad oggi, e che verranno trattate più avanti, è necessario
segnalare come le vicende legate ai conflitti bellici della Seconda Guerra
Mondiale abbiano profondamente alterato la lettura di questi luoghi. Gli
sventramenti causati dai bombardamenti cancellarono i limiti ben definiti e
compatti degli isolati urbani divenendo un continuum spaziale di vuoti, ruderi e macerie. Di tutta
l’insula descritta le alterazioni maggiormente visibili si hanno sul sistema di
piazza del Gran Cancelliere con la perdita della chiesa di San Biagio, del
convento del Gran Cancelliere e del palazzo Lanza; nel sistema di piazza
Bologni l’ala occidentale di Palazzo Ugo e parte dei prospetti dei palazzi che
ne determinano la quinta; sul lato occidentale di Palazzo Riso nel crollo di parte di Palazzo Geraci con la
conseguente chiusura del vicolo di San Biagio.
Oggi sull’area dove insisteva il convento e la chiesa del
Gran Cancelliere sorge una scuola elementare; Palazzo Lanza è stato ricostruito
seguendo un restauro filologico; Palazzo Geraci è stato lasciato a rudere e l’area
su cui sorgeva la chiesa di San Biagio è un grande vuoto unito a quello rimasto
dalla perdita dell’ala occidentale di Palazzo Belmonte Riso.
La posizione strategica ha sempre permesso a questo luogo di
rivestire un ruolo centrale nelle vicende
di Palermo. L’ingresso avviene dalla via Vittorio Emanuele,
nonché l’arteria più antica della città lungo la quale sono presenti numerosi
monumenti palermitani, tanto da aver assicurato alla stessa l’appellativo di via
Marmorea.
La realizzazione del palazzo impegnò l’architetto Marvuglia
per circa quattro anni, a partire dal 1780 fino al giugno 1784 giorno
dell’inaugurazione. Purtroppo non sono stati rinvenuti alcuni disegni o rilievi
redatti dallo stesso architetto ad eccezione del prospetto lungo il Cassaro, ma
all’interno di una raccolta di disegni e incisioni intitolata Architecture moderne de la Sicilie, due
disegni datati 1789, quindi posteriori di solo 5 anni alla realizzazione del
palazzo, hanno attirato la nostra attenzione: un’ipotesi di rilievo della
pianta del piano terra del palazzo, e una sezione centrale che propone il
disegno del prospetto di un’ala del palazzo
nobiliare. I disegni vennero realizzati da Jacob Ignaz
Hittorff, architetto e archeologo tedesco, e dal suo discepolo Karl Ludwig
Wilhelm Zanth.
Sebbene il palazzo si attesti su antiche preesistenze, non è
stata trovata alcuna motivazione per pensare che la nuova fabbrica sia stata
costruita con riferimenti a quella antecedente completamente demolita per
volontà del principe; si può affermare che l’unico condizionamento sia stato
rappresentato dalla forma dell’isolato. La composizione del nuovo palazzo è retta
dal regolare e solenne tracciato ordinatore degli spazi di rappresentanza che
al piano terra si articolano in due cortili introdotti da portici colonnati e
conclusi, al termine di una lunga prospettiva, nello scalone d’onore
incorniciato da due fontane di modeste dimensioni. Intorno ai due cortili si
attestavano vasti locali di servizio: in particolare, nel primo, la
Cavallerizza Grande, la pagliera, le abitazioni degli stallieri e le rimesse
per le carrozze; nel secondo la cucina principale, la carboniera e la cantina.
Secondo la descrizione e i disegni degli architetti tedeschi
Hittorff e Zanth, lo scalone portava, al primo piano a una loggia rivolta sul
secondo cortile. Da qui, dopo una serie di ambienti di rappresentanza, si giungeva
all'appartamento d’apparato, disposto lungo il fronte della via Vittorio
Emanuele II, sopra l’atrio di ingresso e le attigue botteghe e preceduto da una
terrazza aperta sulla prima corte. La camera da letto del principe, così come
la cappella, la stanza degli armadi, vari guardaroba e scale segrete che
conducevano all’ultimo piano, dovevano trovarsi sul lato opposto al percorso
appena descritto.
L’ultimo piano era caratterizzato da una pianta differente
rispetto quella del primo piano: essa si estendeva solo fino il primo cortile,
come visibile dall’ipotesi ricostruttiva in alzato di Hittorff e Zanth.
Tutte queste deduzioni rispetto l’ipotetico assetto
originario di Palazzo Riso sono state possibili grazie i rilievi degli
architetti tedeschi. In aggiunta è stato possibile riscontrare peculiarità tra
sette differenti dimore storiche, compreso Palazzo Riso, tutte di origine
settecentesca e raccolte nel volume Architecture moderne de la Sicilie.
Possiamo sintetizzare in tre punti fondamentali i caratteri tipologici
principali del palazzo urbano settecentesco in Sicilia. In tutti i casi è stata
riscontrata una ricomposizione ordinata attorno a nuovi nuclei fondativi quali,
per esempio, cortili, caratterizzata dalla continua ricerca di valorizzazione dell’enfilade
prospettica secondo l’asse di rappresentanza che dall’ingresso conduce lo
sguardo sino a un elemento architettonico scenografico. In seconda istanza
la realizzazione ex novo di percorsi di rappresentanza distinti da quelli
privati. In ultimo, diverso utilizzo dei piani: piano terra caratterizzato da botteghe
e spazi da affittare, il primo mezzanino come residenza per la servitù e altri
spazi di servizio, al piano nobile sale di rappresentanza, gallerie, e la
camera da letto del nobile, mentre al secondo mezzanino si trovava la residenza
dei restanti membri della famiglia.
 Il prospetto principale di Palazzo Riso sul Cassaro è
fortemente caratterizzato da due ordini: quello basamentale trattato a bugnato,
risulta scandito dall’alternanza di cinque aperture verso strada di cui quella centrale
affiancata da colonne, fa da ingresso al palazzo. Tra le aperture coppie di
lesene sormontate da mensole pendule sostengono la lunga balconata che corre
per tutta la lunghezza del prospetto. Da essa si innalza l’ordine gigante di
paraste con capitelli ionici che, sormontate da una trabeazione di coronamento inquadrano
le aperture del piano nobile e del piano superiore. Sopra gli alternati timpani
curvilinei e triangolari del piano nobile in corrispondenza del balcone
centrale, trova posto lo stemma in marmo della famiglia Ventimiglia sostituito
poi da quello della famiglia Riso. Le aperture del secondo piano presentano ognuna
un balcone sorretto da mensole in calcare.
Il prospetto principale di Palazzo Riso sul Cassaro è
fortemente caratterizzato da due ordini: quello basamentale trattato a bugnato,
risulta scandito dall’alternanza di cinque aperture verso strada di cui quella centrale
affiancata da colonne, fa da ingresso al palazzo. Tra le aperture coppie di
lesene sormontate da mensole pendule sostengono la lunga balconata che corre
per tutta la lunghezza del prospetto. Da essa si innalza l’ordine gigante di
paraste con capitelli ionici che, sormontate da una trabeazione di coronamento inquadrano
le aperture del piano nobile e del piano superiore. Sopra gli alternati timpani
curvilinei e triangolari del piano nobile in corrispondenza del balcone
centrale, trova posto lo stemma in marmo della famiglia Ventimiglia sostituito
poi da quello della famiglia Riso. Le aperture del secondo piano presentano ognuna
un balcone sorretto da mensole in calcare.


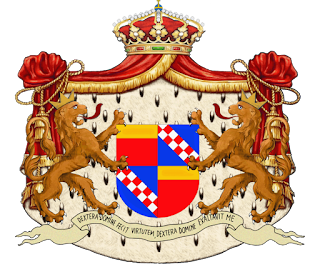

Commenti
Posta un commento