Storia di Belmonte
Il Feudo
Le prime notizie certe del feudo Menzagno risalgono al 2 ottobre 1439, quando viene citato nel
testamento di Pietro di Afflitto. In esso si dice: “Essere stato posseduto il
detto Feudo da’ suoi antichi”.
Pietro lo trasmise ai suoi discendenti in linea primogeniale maschile, successero:
- Baldassarre d'Afflitto fu Pietro.
- Pietro d'Afflitto fu Baldassarre (1441).
- Baldassarre d'Afflitto fu Pietro (1462) morto in minore età; gli successe il fratello .
- Nicolò Antonio d'Afflitto fu Pietro (1462).
- Pietro d'Afflitto fu Nicolò Antonio (1534).
- Vincenzo d'Afflitto fu Pietro (1564);
- Pietro d'Afflitto fu Vincenzo (1576).
Pietro lo trasmise ai suoi discendenti in linea primogeniale maschile, successero:
- Baldassarre d'Afflitto fu Pietro.
- Pietro d'Afflitto fu Baldassarre (1441).
- Baldassarre d'Afflitto fu Pietro (1462) morto in minore età; gli successe il fratello .
- Nicolò Antonio d'Afflitto fu Pietro (1462).
- Pietro d'Afflitto fu Nicolò Antonio (1534).
- Vincenzo d'Afflitto fu Pietro (1564);
- Pietro d'Afflitto fu Vincenzo (1576).
- Vincenzo d'Afflitto fu Pietro (1595).
Alla morte di Vincenzo, alla moglie Elisabetta Morso, fu concesso il titolo di Principessa da Filippo IV il 2 settembre 1627. Questo avvenne dopo che il figlio dei due, Marchisio d'Afflitto, battezzò la Baronia definendola Principato di Belmonte, atto inserito nel Real privilegio di popolare il feudo (Licentia Populandi) concesso dal Re il 22 agosto 1625. Nonostante l’ottenimento della Licentia, il principe Marchisio non riusci a popolare il feudo di Belmonte.
Essendo morto senza figli, a Marchisio successe il fratello Alvaro. Egli sposò Giovanna Alliata, dal loro matrimonio nacque Isabella.
Ella sposò Agesilao Bonanni, Morta Isabella senza figli, il titolo fu ereditato dal cugino Vincenzo (1648).
Egli sposò Ninfa Bellacera, dal loro matrimonio nacque Gerardo Melchiorre d'Afflitto.
Questi sposò Giovanna Gaetani, dal loro matrimonio nacque Ninfa d'Afflitto, ultima erede della casata.
Ninfa d'Afflitto sposò Francesco Ventimiglia separando i destini di Belmonte da quelli della famiglia d'Afflitto. infatti, da allora il feudo Belmonte passò tra i possedimenti della nobile famiglia Ventimiglia.
Alla morte di Vincenzo, alla moglie Elisabetta Morso, fu concesso il titolo di Principessa da Filippo IV il 2 settembre 1627. Questo avvenne dopo che il figlio dei due, Marchisio d'Afflitto, battezzò la Baronia definendola Principato di Belmonte, atto inserito nel Real privilegio di popolare il feudo (Licentia Populandi) concesso dal Re il 22 agosto 1625. Nonostante l’ottenimento della Licentia, il principe Marchisio non riusci a popolare il feudo di Belmonte.
Essendo morto senza figli, a Marchisio successe il fratello Alvaro. Egli sposò Giovanna Alliata, dal loro matrimonio nacque Isabella.
Ella sposò Agesilao Bonanni, Morta Isabella senza figli, il titolo fu ereditato dal cugino Vincenzo (1648).
Egli sposò Ninfa Bellacera, dal loro matrimonio nacque Gerardo Melchiorre d'Afflitto.
Questi sposò Giovanna Gaetani, dal loro matrimonio nacque Ninfa d'Afflitto, ultima erede della casata.
Ninfa d'Afflitto sposò Francesco Ventimiglia separando i destini di Belmonte da quelli della famiglia d'Afflitto. infatti, da allora il feudo Belmonte passò tra i possedimenti della nobile famiglia Ventimiglia.
I Ventimiglia principi di Belmonte
I Ventimiglia costituiscono una linea
di discendenza siciliana di un lignaggio ligure, di probabile origine
franca, reale e imperiale, molto potente e influente nella storia
culturale, politica ed economica dell'isola - e non solo - dal XIII
secolo al XIX secolo. Per lunghi tratti della seconda metà del
Trecento ressero un'ampia signoria indipendente, riconosciuta, tra
gli altri, dallo Stato della Chiesa, nel periodo dei cosiddetti
Quattro Vicari del Regno di Sicilia.
Fra i rappresentanti più importanti e
in vista della nobiltà in Sicilia, i Ventimiglia presero il nome
dalla città ligure di Ventimiglia della quale però non erano i
conti, ma detenevano soltanto piccole quote signorili in condominio
con i cugini del ramo principale, cioè i Lascaris, detentori della
contea di Ventimiglia in qualità di ramo primogenitale.
Il lignaggio trasferitosi in Sicilia,
al contrario, proveniva dal comitato episcopale di Albenga, in cui
deteneva la contea del Maro e il feudo delle decime episcopali. Da
qui, la denominazione di questa branca Ventimiglia del Maro. Dopo la
metà del XIII secolo i Ventimiglia del Maro cedettero ogni residuo
diritto sulla contea di Ventimiglia, signoria che rimase totalmente
in possesso dei Lascaris di Ventimiglia (ramo primogenito dei
Ventimiglia).
I Ventimiglia del Maro in Sicilia
dettero vita a due lignaggi principali: quello dei conti-marchesi di
Geraci e quello dei del Bosco Ventimiglia. Il ramo della famiglia
Ventimiglia futuri principi di Belmonte, deriva da quello dei
marchesi di Geraci. Questo lignaggio deriva da Enrico II Ventimiglia,
nato nel 1230 e morto nel 1307, egli fu conte di Ventimiglia, del
Maro, di Geraci e di Ischia Maggiore, signore di Gangi e delle
Petralie, signore di Gratteri e Isnello, Caronia, Belici, Fisauli,
Montemaggiore, capitano e vicario generale di re Manfredi di Svevia.
Espropriato da Carlo I d'Angiò dei feudi, sia in Sicilia sia in
Liguria, Enrico ne ottenne la restituzione attraverso l'alleanza con
la Repubblica di Genova e con Federico III di Aragona. Fu
ambasciatore degli Aragonesi di Sicilia a Genova nel 1300.
Il pronipote di Enrico, Francesco II,
alla sua morte, avvenuta nel 1387, divise per testamento in due parti
le sue proprietà per destinarle a due dei suoi numerosi figli. A
Francesco III diede il Marchesato di Geraci, ad Antonio destinò la
Contea di Collesano, sarà il suo lignaggio ad ottenere il feudo di
Belmonte.
Il discendente di Antonio, Don Francesco Ventimiglia – nel XVII secolo – fu, infatti, colui che unì definitivamente i destini di Belmonte con quelli della famiglia Ventimiglia, sposando Donna Ninfa Afflitto, titolare del feudo, diventa, infatti, Principe di Belmonte, oltre a questo era già Conte di Collesano Barone di Gratteri e di Santo Stefano di Bivona.
Dal matrimonio di Don Francesco Ventimiglia con Ninfa d'Afflitto nacque Gaetano Ventimiglia; egli s'investi del titolo di Principe di Belmonte il 18 novembre 1697. Gaetano non prese moglie-
A Gaetano successe il fratello Vincenzo che sposò Maria Anna Statella. Dal loro matrimonio nacque Giuseppe Emanuele III Ventimiglia principe di Belmonte e fondatore del paese.
Il discendente di Antonio, Don Francesco Ventimiglia – nel XVII secolo – fu, infatti, colui che unì definitivamente i destini di Belmonte con quelli della famiglia Ventimiglia, sposando Donna Ninfa Afflitto, titolare del feudo, diventa, infatti, Principe di Belmonte, oltre a questo era già Conte di Collesano Barone di Gratteri e di Santo Stefano di Bivona.
Dal matrimonio di Don Francesco Ventimiglia con Ninfa d'Afflitto nacque Gaetano Ventimiglia; egli s'investi del titolo di Principe di Belmonte il 18 novembre 1697. Gaetano non prese moglie-
A Gaetano successe il fratello Vincenzo che sposò Maria Anna Statella. Dal loro matrimonio nacque Giuseppe Emanuele III Ventimiglia principe di Belmonte e fondatore del paese.
Giuseppe Emanuele III Ventimiglia principe di Belmonte
Da enciclopedia Treccani:
Giuseppe Emanuele III Ventimiglia
principe di Belmonte nacque a Palermo, l'8 luglio 1716, da Vincenzo
Ventimiglia e da Maria Anna Statella.
Nel 1725, alla morte del padre, ereditò
le sue proprietà divenendo quindi: Principe di Belmonte, Conte di
Collesano, di S. Eufemia, Conte di Parma, Barone di Gratteri, Lascari
e di S. Stefano di Bivona, signore degli stati e terre delle
Rosselle, del Mezzagno, S. Biagio, Suro, Purace, Carbone, Chianetti,
Pinato, Bappadi, Magagirafì, Amizzo, Contuberno, Finocchiara,
Misita, Noro, Castagna, Donna, Margiamuto, Norazzio, Prato,
Fontanelli, Bosco, Canneti, S. Pietro, marine del Pileto e della
Bomana ecc.
Il 17 settembre 1736 viene nominato
capitano di giustizia della città di Palermo, questo costituirà il
primo passo verso incarichi più impegnativi nelle magistrature
siciliane. Infatti, nel maggio del 1744 viene nominato "pretore"
e messo così a capo dell'amministrazione palermitana.
Il giovane patrizio si rivelò alacre
ed attivo: ancor prima di entrare in possesso del suo ufficio
segnalava al viceré gli inconvenienti e disservizi notati nei
diversi rami della pubblica amministrazione. Egli denunciava ritardi
nell'organizzazione degli approvvigionamenti di carne, incuria
nell'accantonamento delle scorte di grano, destinazione di entrate
pubbliche a scopi diversi da quelli per cui erano state introitate,
ritardi nella stesura dei contratti di concessione delle gabelle. In
ultimo notava che una parte delle somme esistenti nel fondo di
riserva, creato dal Senato per sopperire ad eventuali minori
introiti, era stata prelevata e destinata, senza che sussistessero le
condizioni di emergenza previste, ad altri scopi.
A questa chiara visione delle necessità
della cosa pubblica rispondeva in Giuseppe Emanuele la capacità di
assumere pronte iniziative. Lo dimostrano i provvedimenti di difesa
militare da lui adottati, ad esempio quando, in seguito ad una
pressante richiesta vicereale, prevenì l'attacco d'una squadra
navale inglese, grazie ad un sollecito intervento in Senato.
La carica di "pretore" lo
mise, tra l'altro, a capo della Suprema generale deputazione di
Salute pubblica che aveva il compito di organizzare e coordinare
tutti i servizi sanitari dell'isola. Egli svolse le funzioni di
quest'ufficio in un momento particolarmente delicato, mentre ancora
imperversava in Messina e nella zona circostante l'epidemia colerica
esplosa l'anno prima; sua prima preoccupazione fu, pertanto,
riorganizzare i servizi della Deputazione e dare disposizioni perché
un rigoroso isolamento venisse assicurato alla zona infetta col
rafforzamento dei cordoni di truppa esistenti intorno ad essa.
Nel maggio del 1745 il Principe
concluse questa esperienza di pubblico amministratore e, possiamo
dire, positivamente, tanto è vero che a distanza di pochi anni, nel
maggio del 1748, venne di nuovo chiamato allo stesso incarico. Nel
1750 e nel 1758 fu deputato del Regno, nel 1751 venne chiamato dal
viceré a far parte della Deputazione dei proietti, nominata per
organizzare in tutta l'isola servizi idonei a proteggere l'infanzia
abbandonata.
Nel 1752 Giuseppe Emanuele Ventimiglia
chiese ed ottenne, da re Carlo III, la “licentia populandi"
per il feudo di Belmonte, nascerà così Belmonte Mezzagno.
Nel 1757 venne nominato, per la seconda
volta, capitano di giustizia. La validità dell'opera da lui svolta
trovò riconoscimento anche presso la corte napoletana: nel 1759
Carlo III di Borbone, nel lasciare il Regno – per prendere la
Corona spagnola – gli concedeva il cordone di S. Gennaro e lo
nominava gentiluomo di camera del suo giovane successore, Ferdinando
IV. Iniziava così il cursus honorum del Principe presso la corte
borbonica: l'anno seguente il consiglio di reggenza lo inviava a
Venezia come ambasciatore straordinario per comunicare ufficialmente
al governo della Repubblica l'avvento di Ferdinando IV al trono delle
due Sicilie. Egli, che era giunto a Venezia nel giugno del 1760, vi
si trattenne fino al gennaio del 1761, data del suo ritorno a Napoli,
ove prese a risiedere per svolgervi le sue mansioni di gentiluomo di
camera del sovrano. Nel giugno 1767 venne nominato maggiordomo
maggiore della regina, due anni dopo maggiordomo maggiore del re e
nel settembre 1771, da Carlo III, grande di Spagna di prima classe.
Giuseppe Emanuele Ventimiglia morì il
2 marzo 1777, a San Giorgio a Cremano, presso Napoli.
La Licentia Populandi
Adesso vediamo meglio cos’era la
Licentia Populandi e che diritti dava al suo possessore.
La Licentia Populandi veniva concessa
come ricompensa per particolari servigi resi alla corona. Con la
licenzia il feudatario acquisiva la giurisdizione civile e penale sul
paese e sugli abitanti.
Prestigio e vanità erano fattori che
inducevano i feudatari a popolare le loro terre. Ma i veri motivi
erano da ricercare negli enormi vantaggi economici e politici che
l'impresa poteva offrire. Infatti, connesso con la giurisdizione
feudale era il governo politico, economico e sociale della nuova
popolazione. E qui insieme alla possibile smania di vanità, il
barone soddisfaceva anche precise aspettative economiche. La più
appariscente era la riscossione delle tasse. Inoltre, un nobile che
fondava un nuovo comune con almeno ottanta case aveva diritto al
titolo di principe e un seggio nel Parlamento siciliano, veniva cioè
elevato al ruolo di Grande di Spagna.
Ma più consistenti erano i vantaggi
derivanti dalla messa a coltura delle terre baronali; da questo punto
di vista, ogni nuova famiglia che si trasferiva nel nuovo centro
abitato era una nuova unità produttiva che si poneva al servizio del
feudatario. Ciò accadeva in un particolare momento storico durante
il quale la mancanza di grani in Sicilia diventata assillante ed era
difficile potersene procurare nel bacino del Mediterraneo. La
scarsità dei grani aveva provocato il comprensibile rialzo dei
prezzi per cui il prodotto era abbastanza remunerativo per chi avesse
voluto dedicarsi alle colture.
Naturalmente l’impresa non era esente
da rischi. In quanto presupponeva un notevole investimento anticipato
di capitali per la costruzione delle case, delle strade, della
chiesa, del fondaco e per le anticipazioni sul raccolto che nel caso
di fallimento dell'operazione (se ad esempio, in tempi brevi non si
fossero trasferiti numerosi coloni dai paesi vicini a popolare il
nuovo centro) potevano andare perduti. A tale scopo molti feudatari
non solo concedevano gratuitamente il terreno per la fabbrica delle
case ai singoli coloni, ma esentavano gli stessi per un decennio dal
pagamento dei tributi e dei servizi feudali.
Importantissime, per la buona riuscita
dell’investimento erano la scelta del sito e le condizioni (patti
agrari) offerte dal feudatario ai nuovi coloni. È ovvio che il
feudatario per attirare nel comune appena fondato coloni dei paesi
vicini, doveva offrire condizioni migliori di quelle esistenti nei
paesi circostanti. La scelta del luogo dove insediare l’abitato
doveva essere attentamente studiata. Era fondamentale la presenza
dell'acqua, la vicinanza alle strade carrabili e a cave per il
materiale da costruzione, terreno fertile da poter concedere in
enfiteusi e in quantità tale da costituire un incentivo per i futuri
abitanti; si e constatato che quasi sempre i nuovi comuni sorsero in
siti dove esisteva già una qualche struttura abitata, fosse essa un
casale, un piccolo agglomerato di case o altro.
Chiesa Madre S.S. Crocifisso
La Chiesa è collocata nella parte
superiore della piazza principale, nel centro del paese.
Artisticamente c'è da notare: il Prospetto imponente ma equilibrato
e una bella e originale scalinata a due bracci, scalone realizzato
sulle orme delle ville settecentesche che si rifà ai temi del tardo
barocco a cui del resto si ispira tutto il prospetto.
Il corpo della Chiesa ha una superficie
di 200 mq.; la facciata si innalza per circa 30 mt. La costruzione
della Chiesa, iniziata nel 1772, è stata completata dopo 4 anni. E'
stata eretta canonicamente il 26 febbraio 1776.
Di notevole pregio, al centro del
prospetto sopra il portale, è lo stemma dei Ventimiglia. Ai lati di
esso il Principe di Belmonte, tenne molto alla posa di due lastre
marmoree, recanti delle scritte che sono il "Curriculum" di
sé:
D.O.M.
JOSEPHUS EMMANUEL VENTIMILLIUS
NORMANNUSS SVEVUS ARAGONEUS;
UT AD ARAM HUIUS TEMPLI
PROPRIO AERE EXTRUCTI
SACRIS QUOTIDIE QUATOR
DEO O.M. LITETUR,
PERPETUO INSTITUIT
QUAE ANIMABUS CARISSIMIS
MARIAE ANNAE STATELLAE
MATRIS OPTIMAE
ET ISABELLAE ALLIATAE
CONIUGIS DULCISSIMAE
SIBIQUE EXTREMA PRAEVIDENTI
AC POPULI HUIUS RELIGIONI ESSENT
PROFUTURA
A Dio Ottimo Massimo
Giuseppe Emanuele Ventimiglia Normanno,
Svevo, Aragonese. Perché ogni giorno si celebrassero i Sacri Misteri
a Dio Ottimo Massimo all'Altare di questo tempio costruito nel
proprio feudo, in perpetuo istituì. Affinché le Verità Eterne
fossero di giovamento alle anime carissime di Maria Anna Statella
ottima Madre e di Isabella Alliata dolcissima coniuge, a se stesso, e
alla religione di questo popolo.
D.O.M.
JOSEPHUS EMMANUEL VINTIMILLIUS
COMES ALBINTEMELII, GOLISANI,
GRATTERI, LASCARIS, ET SANCTI STEPHANI
PRINCEPS BELLIMONTIS EX PRIMO MAGNATUM
HISPANORUM ORDINE
EQUES SANCTI JANUARII
POST TERTIAM IN URBE PANORMITANA
QUAESTURAM MALEFICIORUM
ALTERAMQUE PRAETURAM,
TERTIO XII=VIR REGNI CURATORUM
REGIUS AD VENETOS SOLEMNITER LEGATUS;
REGI CAROLO A CUBICULO.
DOMUS REGIS FERDINANDI
SUPREMUS PRAEFACTUS
OPPIDO AEDIFICATUM INCOLIS ACCITIS
TEMPLUM A FUNDAMENTIS EXCITAVIT
A.D. MDCCLXXVI.
A Dio Ottimo Massimo
Giuseppe Emanuele Ventimiglia Conte di
Albitemeli, di Collesano di Gratteri, di Lascari e di S. Stefano,
Principe di Belmonte, Cavaliere di S. Gennaro del Primo ordine dei
Grandi di Spagna. Tre volte questore e due volte pretore nella città
Palermitana, uno dei dodici pari del regno, ambasciatore regio ai
Veneti, supremo prefetto del Re Carlo dalla Nascita, della casa della
Regina Carolinae quindi del Re Ferdinando. Edificata la città,
accolti gli abitanti, questo tempio innalzò dalle fondamenta.
Anno del Signore 1776.
 L'interno della Chiesa, a navata unica,
è arricchito all'abside da un magnifico crocifisso voluto, intorno
al 1772, da Giuseppe Emanuele Ventimiglia che ne curò personalmente
la realizzazione.
L'interno della Chiesa, a navata unica,
è arricchito all'abside da un magnifico crocifisso voluto, intorno
al 1772, da Giuseppe Emanuele Ventimiglia che ne curò personalmente
la realizzazione.
Oltre a questo ne fece costruire un
altro per la Chiesa di Santo Stefano di Quisquina: altro borgo
presente nei suoi possedimenti.
Il crocifisso ligneo, di sicura scuola
napoletana, sofferma lo sguardo dell'osservatore su un Cristo
morente, quindi sofferente ma ancora vivo.
Notevoli sono i due Altari nelle pareti
laterali della Chiesa: su di essi si trovano due grandi tele,
raffiguranti una S. Rosalia l'altra la S. Famiglia: attribuite alla
scuola di Pietro Novelli.
A meta navata, sulla destra, è
visitabile il Battistero di S. Giovanni Battista; arricchito da un
altare dedicato all'Immacolata Concezione.
Uscendo, nella parte alta, è visibile
il coro e l'imponente organo a canne.
Giuseppe Emanuele IV
Ventimiglia Cottone principe di Belmonte
Degna di nota, è la figura
del nipote ed omonimo del fondatore del paese.
Giuseppe Ventimiglia nacque
a Palermo nel 1766, figlio primogenito del principe Vincenzo e di sua
moglie, Anna Maria Cottone di Castelnuovo, di tradizioni
costituzionaliste. Sin dalla gioventù venne inviato a studiare a
Roma presso il Collegio del Nazareno per poi dedicarsi ad un gran
tour in Europa, toccando tappe importanti come il viaggio in Italia,
Svizzera, Impero, Ungheria e Polonia. Durante quest'ultimo viaggio
conobbe ed accompagnò il sovrano Stanislao Poniatowski al suo primo
incontro con la zarina Caterina II, facendo quindi seguito
all'imperatrice sino a Kiev ed a Kherson, navigando lungo il Dnieper.
Giunto in Crimea, da qui raggiunse la Moldavia e la Valacchia facendo
tappa a Bucarest, attraversando poi la Prussia, la Sassonia e quindi
giungendo in Francia ed in Inghilterra. Tornato a Parigi, qui conobbe
sua cugina Charlotte Ventimille, del ramo francese della sua
famiglia, e la sposò prima di fare ritorno con lei in patria.
L'ambiente culturale che
ritrovò a Palermo era intriso dei personaggi patrocinati da suo zio
Carlo, principe di Castelnuovo, ed ebbe perciò corrispondenze con
l'astronomo Giuseppe Piazzi e con Paolo Balsamo tra gli altri. Si
batté negli inizi dell'Ottocento per il mantenimento dell'Accademia
Palermitana degli Studi, minacciata di chiusura dallo stesso re
Ferdinando IV che era intenzionato a ripulirla dell'impronta
libertaria che aveva assunto ed a restituirla ai gesuiti.
In quegli anni re Ferdinando
viveva in Sicilia perché Napoli era occupata dalle truppe francesi
guidate dal maresciallo dell’impero di Francia – nonché cognato
di Napoleone – Gioacchino Murat. Ferdinando IV riusciva a soffocare
sul nascere ogni tentativo di rivolta del popolo siciliano, il quale
non sopportava l’idea che la Sicilia fosse considerata dal Re
subalterna rispetto a Napoli, grazie all’appoggio dell’esercito
inglese.
Il Belmonte fu uomo di idee
liberali, per questo presto divenne una delle figure chiave quando
gli inglesi si adoperarono per restituire ai Borbone la loro corona
nell'Italia meridionale, dopo la caduta dei francesi: lord Horwick
(futuro conte Grey e primo ministro inglese) lo teneva in grande
considerazione per una possibile intesa anglo-sicula al fine di
sconfiggere il "partito" dei sostenitori della regina Maria
Carolina che appoggiava i francesi di Murat. Proprio per questo scopo
il Ventimiglia si pose a capo di 30.000 uomini armati volti a
difendere la forma di governo esistente contro la proprietà dei
particolari e i privilegi dei diversi ordini. Tra questi privilegi
che il Ventimiglia riteneva ormai intollerabili vi era una sorta di
tassa fissa che la Sicilia doveva pagare al governo di Napoli senza
motivazione e che rimandava a una specie di donativo medievale; egli
propose al contrario una imposta fondiaria basata su un catasto da
preparare e solo in seguito una eventuale imposta indiretta per
coprire il gettito eventualmente insufficiente.
Appoggiò apertamente Luigi
Filippo d'Orléans, genero del re, e chiese alla regina
l'allontanamento dei ministri napoletani, nonché la fondazione di
una amministrazione siciliana indipendente, dove i baroni potessero
avere un ruolo significativo nel governo centrale una volta che
Napoli fosse stata riconquistata alle truppe dei napoleonici. Assieme
ad altri 43 baroni, il Ventimiglia venne però arrestato la notte tra
il 19 ed il 20 luglio del 1811 e con altri tre venne rinchiuso nel
castello di San Giacomo a Favignana. L'accusa ufficiale furono una
serie di lettere che il governo aveva intercettato, nelle quali il
principe dimostrava di avere una corrispondenza col principe
ereditario d'Inghilterra, nel quale egli paventava, se necessario,
una volontà da parte del popolo siciliano di utilizzare anche le
armi contro il governo per far valere i propri diritti, e dove
chiedeva un appoggio ufficioso della Gran Bretagna a queste
operazioni. Rimase in prigionia, malgrado lo stato di salute
precario, sino al 20 gennaio 1812 quando venne liberato per
intervento di lord Bentinck.
Da subito il Ventimiglia con
altri si adoperarono per la stesura di una prima costituzione
siciliana che si rifacesse il più possibile a quella inglese, che
rappresentava a sua detta un modello ideale di connubio tra
democrazia e monarchia: il risultato fu la Costituzione siciliana del
1812.
Col congresso di Vienna, re
Ferdinando tornò al potere ufficialmente anche sul trono siciliano e
come risultato il Ventimiglia ed i suoi alleati vennero allontanati
dai centri di potere. Nel tentativo estremo di salvare la
costituzione siciliana in cui tanto aveva creduto, e per la quale si
era battuto per un decennio, si recò a Parigi dove venne ricevuto da
Luigi XVIII di Francia che, pur complimentandosi largamente con lui,
non si impegnò a fare pressioni al governo borbonico perché
riconoscesse delle assicurazioni politiche per la Sicilia e la sua
costituzione.
Morì a Parigi, ormai minato
irrimediabilmente dalla tisi, nell'ottobre del 1814.
I moti rivoluzionari del
1848-49
Nel gennaio del 1848, in Sicilia
scoppiò un'insurrezione popolare, a cui successivamente si aggiunse
la borghesia popolare, mossa soprattutto dalla volontà di
ripristinare la Costituzione del 1812. La rivoluzione siciliana
scoppiò il 12 gennaio 1848 in Piazza della Fieravecchia (oggi Piazza
Rivoluzione) a Palermo, capitanata da Giuseppe La Masa. Dopo
sanguinosi scontri, La Masa, al comando di un esercito popolare,
riuscì a scacciare la luogotenenza generale e gran parte
dell'esercito borbonico dalla Sicilia, costituendo un «comitato
generale rivoluzionario». Il comitato generale istituì un governo
provvisorio a Palermo; tra le felicitazioni generali e l'ottimismo,
Ruggero Settimo, un liberale moderato appartenente alla nobiltà
siciliana, venne nominato presidente. L'estensione del movimento
insurrezionale alla Campania ed al resto del regno fu immediato. Il
Re, dopo alcuni tentativi di frenare il movimento con caute
concessioni, cercò di arginare le richieste liberali concedendo la
Costituzione, per primo in Italia, con Regio Decreto del 29 gennaio.
La Costituzione venne promulgata l'11
febbraio e giurata il 24; Il 25 marzo del 1848 si riunì il
Parlamento Generale di Sicilia, con un governo rivoluzionario
presieduto da Ruggero Settimo e composto da ministri eletti dallo
stesso presidente, che proclamò l'indipendenza dell'isola,
nonostante l'appoggio concreto delle città siciliane al governo
provvisorio di Settimo, le aree rurali divennero scarsamente
controllate e agitazioni contadine misero in serie difficoltà le
amministrazioni locali. Re Ferdinando, approfittando di questo, non
fece tardare la sua reazione, decidendo di intraprendere una risoluta
restaurazione assolutistica.
Nel settembre 1848, dopo aver
richiamato in patria l'armata napoletana schierata in Lombardia ed
aver sospeso le attività parlamentari, il Re decise di reprimere con
la forza anche il separatismo siciliano, sopprimendo la rivoluzione e
il Parlamento che da questa era stato eletto.
La gente di Sicilia, man mano che
sentiva del ritorno dei Borbone, scappava di solito nelle montagne; e
i Borbone, non vedendo nei paesi la gente, pronta ad accoglierli,
distruggevano gli stessi paesi. Sorte che tocco a Belmonte Mezzagno.
Tutto cominciò il 7 maggio 1849 - già
da qualche giorno i belmontesi erano fuggiti sulle montagne - verso
le 7 di sera il generale Prono arrivò in paese con parte
dell'esercito borbonico, ad accoglierlo trovò soltanto l'economo
sacramentale Padre Luigi Mario Furitano, e il cappellano celebratario
della Chiesa Miseremini (Anime Sante) Padre Angelino Moltisanti (in
"nomen omen"). I due ministri andarono verso il Generale
offrendo pace assicurando la fedeltà del popolo belmontese a re
Ferdinando, affinché, il Generale non distruggesse il paese. Egli
accettò l'offerta, Padre Furitano, come segno di riconoscenza,
benedisse lui e l'esercito con l'ostensorio contenente il SS.
Sacramento.
Le paure del Reverendo l'indomani, 8
maggio 1849, purtroppo, si concretizzarono: squadre ribelli venute da
Palermo attaccarono i soldati nei monti intorno al paese, vedendo
questo il Generale, dopo aver scacciato i ribelli, ordinò la
distruzione del borgo. I soldati eseguirono l'ordine, lasciando in
piedi soltanto la Chiesa Madre e la Chiesa Miseremini.
L'esercito rimase in paese 7 giorni,
prima di rientrare a Palermo.
Quando l'esercito scomparve, i
belmontesi scesero dai monti trovando le proprie case ormai ridotte
in ceneri fumanti. Ai due Reverendi rimase l'orrore negli occhi e un
popolo da consolare.
Belmonte nell'unità
d'Italia
Dopo la distruzione del paese per mano
delle truppe borboniche del 1848, con l'odio verso Ferdinando II che
non era mai stato così alto, cominciò la ricostruzione di Belmonte.
I belmontesi per la ricostruzione delle
proprie case non ricevettero alcun aiuto governativo, quindi,
nonostante il "Real" incendio delle campagne, dovettero
cavarsela da soli; ottennero soltanto di non pagare tasse. Ciò
solamente fino al 1850, quando i belmontesi ancora alla fame
dovettero ricominciare a pagare i tributi, per questo da quel giorno
Belmonte divenne uno dei principali centri organizzativi della
rivolta contro i Borbone. Tale odio cominciò a divenire movimento
organizzato nel febbraio 1853, quando furono organizzati convegni a
Parco (Altofonte), Belmonte, Mislmeri e Carini volti a preparare la
rivolta. Dopo vari tentativi, il momento giusto sembrò essere
arrivato il 4 aprile 1860, quando, a suono delle campane del convento
palermitano della Gancia, Francesco Riso e i suoi 84 compagni, fra i
quali numerosi belmontesi, tentarono con le armi di entrare nella
capitale. Il tentativo, anche a causa della scarsa efficacia delle
armi dei rivoltosi, falli ma fu il segnale che Garibaldi aspettava
...
Il 1° maggio 1860, dopo aver
raggruppato un migliaio di volontari, la maggior parte dei quali del
bergamasco, Garibaldi venuto a sapere del fermento rivoluzionario
siciliano, diede l'ordine di partire.
Nella notte tra il 4 e il 5 maggio,
Garibaldi e i "mille" salparono da Quarto su due piroscafi,
il Lombardo e il Piemonte, e, dopo una breve sosta nell'isola di
Talamone, l'11 maggio sbarcarono a Marsala. Il 15 maggio i
garibaldini si scontrarono a Calatafimi (TR) con le truppe
borboniche. Soprattutto a causa della scarsa preparazione degli
ufficiali borbonici, che fecero moltissimi errori di strategia; i
"mille" vinsero la battaglia e cominciarono ad avanzare
verso Palermo.
Nei territori limitrofi a Palermo,
cominciarono a sorgere truppe di irregolari a sostegno dei
garibaldini. Tali squadriglie erano gestite da La Masa, egli radunò
le truppe, forti di 5000 uomini provenienti da Belmonte, Mislmeri,
Mezzoiuso, Corleone e altri paesi del circondario,a Gibilrossa.
Belmonte Mezzagno, essendo il paese più vicino all'accampamento,
servì da base strategica delle operazioni.
Il 20 maggio Garibaldi, ormai giunto a
Misilmeri, volse alla volta di Belmonte in testa a 6000 uomini, che
lo accolse con entusiasmo. Il 24 maggio, nelle campagne di Belmonte
si svolse una sanguinosa battaglia fra le truppe borboniche e i
garibaldini in gran parte formati da belmontesi. L'esito fu funesto
per Garibaldi ma egli non si arrese, aiutato da La Masa il 25 maggio
spinse gli avamposti nelle alture di Belmonte e con esse l'indomani
sera inizio la discesa verso Palermo. Conquistata la città il 30
maggio, tutta la Sicilia venne rapidamente liberata; infatti, il 28
luglio l'ultimo soldato borbonico lasciò la Sicilia.
Il 21 ottobre 1860, anche a Belmonte si
svolse il plebiscito (il referendum) per l'annessione del paese al
nascente Regno d'Italia. Chiaramente le votazioni non avevano le
garanzie che oggi le contraddistinguono: non era garantita la
segretezza del voto, spesso espresso in modo palese con il sì spesso
estorto dai signorotti locali con modi assai poco democratici.
A Belmonte il popolo si espresse
favorevolmente all'annessione, più che altro perché credevano che
con i piemontesi non avrebbero più avuto fame; queste erano le
promesse. Molte di queste purtroppo vennero disattese causando
numerose rivolte, la più sanguinosa fu quella del 7 e mezzo del 15
settembre 1866; che in Sicilia causo oltre 25 mila morti.
La fame a Belmonte continuò ancora a
lungo e fu la principale causa della partecipazione del paese ai
fasci siciliani.
Stefano Casella
Adesso propongo
la storia di un belmontese dell'Ottocento. Tale approfondimento è
stato realizzato da una grande appassionata di storia belmontese
Joanna Calabrese Wilson, discendente come me del protagonista di
questa storia; si tratta di Stefano Casella (il vecchietto nella
foto), nato a Belmonte nel 1804 e morto nel 1892, di cui io per una
serie di vicissitudini porto il nome: suo nipote Stefano (che portava
il suo nome) era zio di mio nonno (fratello di sua madre Francesca
Casella) nonché suo padrino di battesimo, siccome mio nonno era il
più piccolo di 4 fratelli e una sorella lo chiamarono come il
padrino. Io, portando il nome di mio nonno, di conseguenza porto il
nome di Stefano Casella, suo bisnonno.
Ed ora ecco il contributo di
Joanna:
Stefano nacque nel 1804 a
Belmonte Mezzagno, in Sicilia, un paese insediato sulle colline fuori
Palermo. La vita del paese ruotava attorno a famiglia, fede e
agricoltura. Come molti ragazzi del paese, egli era figlio di un
contadino che crebbe per diventare contadino a sua volta. All’età
di 24 anni, Stefano sposò la diciannovenne Liboria D’Agostino.
Iniziarono subito la loro famiglia, e la piccola Giuseppa nacque
l’anno seguente.
Pandemia
Sfortunatamente, anche un
piccolo batterio di nome vibrio cholerae era appena agli inizi.
Prosperando nell’acqua da
bere contaminata, il colera si diffuse rapidamente in ampie sezioni
del globo, inclusa la Sicilia. La piccola Giuseppa di due anni fu la
prima a perire, nel 1831. Stefano e Liboria ebbero in seguito altri
sette figli, ma almeno due se ne andarono prima del 1840. Poi accade
l’impensabile: nell’estate del 1845, la stessa Liboria morì,
seguita il mese successivo da sua figlia di 10 mesi, Alfonsa.
Stefano era adesso un padre
solo con quattro figli da accudire. Fortunatamente, i suoi figli
sopravvissuti, dai 9 ai 14 anni, erano abbastanza grandi per aiutare
in casa e nei campi.
Rivoluzione Siciliana
La perdita personale di
Stefano aveva come sfondo una sommossa politica in Sicilia. La
crescente insoddisfazione nei confronti della casa reale dei Borboni
fu lo sprone di diverse rivoluzioni. La rivolta popolare del 1848 fu
ampiamente sostenuta a Belmonte Mezzagno. Per ritorsione, l’esercito
dei Borboni invase il villaggio l’8 maggio 1849, causando la fuga
degli abitanti del paese sulle colline. Il quarantaquattrenne Stefano
e i suoi figli si trovavano fra di loro. Tra i fuggiaschi sulle
colline si trovava anche la trentaduenne Eleonora Benigno con sua
figlia di otto anni, Giuseppa Capizzi. Proprio come Stefano, Eleonora
aveva perso il coniuge, Giovanni Capizzi, nel 1845, oltre a suo
figlio più giovane.
L’esercito dei Borboni
rimase per una settimana, per poi ritirarsi. Gli abitanti discesero
dalle colline e scoprirono che ogni edificio del paese era stato
ridotto in cenere, fatta eccezione per due chiese. Stefano e i suoi
figli dovettero ricominciare daccapo. Ancora una volta. Stessa cosa
per il resto di Belmonte, inclusa Eleonora e sua figlia.
Conforto
I documenti non rivelano
perché Stefano ed Eleonora finirono assieme. Forse compresero il
lutto e la perdita l’uno dell’altra come pochi altri potevano. A
prescindere dal motivo, si sposarono nel 1851. La famiglia allargata
comprendeva Stefano, Eleonora e i loro cinque figli superstiti. In
seguito ebbero altri figli propri, nominando i primi due come i loro
defunti coniugi, Liboria e Giovanni.
In attesa
La nuova famiglia Casella
non era però estranea al dramma. Nel 1856, la figlia allora
quindicenne di Eleonora, Giuseppa Capizzi, rimase incinta. Lei e il
figlio ventitreenne di Stefano, Giuseppe, desideravano sposarsi.
Questo presentò un dilemma più grande del solito perché Giuseppa
non aveva un padre in vita o un nonno che potesse dare il consenso al
matrimonio per la minorenne. Le autorità decisero di accettare il
permesso congiunto di Stefano ed Eleonora. Stefano scrisse nel suo
decreto di consenso che egli era “contenta chi il da lui figlio
Giuseppe Casella inguaggiare (legare con promessa di matrimonio) con
Giuseppa Capizzi.” Eleonora scrisse che era “contenta che la
detta di lei figlia Giuseppa Capizzi si pocca inguaggiare con indetto
Giuseppe Casella.”
“Contenta” e “contenta”
– quali meravigliose parole da sentire da Stefano ed Eleonora dopo
tutto quello che avevano sopportato. I fratellastri si sposarono il
28 luglio 1856, e la piccola Liboria (sì, un’altra Liboria) nacque
3 mesi più tardi – la prima nipote di molti per Stefano.
Ciò che hanno visto gli
occhi
Stefano Casella morì nel
1892 all’età di 87 anni. La sua vita abbracciò la gran parte del
19º secolo. Riuscii ad assistere - e forse a partecipare - alla
liberazione della Sicilia sotto Giuseppe Garibaldi, all’unificazione
dell’Italia, e ai progressi tecnologici come il trasporto su rotaie
e l’avvento della fotografia. Anche se Stefano attraversò calamità
inimmaginabili durante la prima metà della sua vita, alla fine
riuscì a vedere cambiare la sua terra natia, vide prosperare i suoi
figli e vide crescere i suoi nipoti. Riuscì a vivere anche per
accogliere l’arrivo dei bisnipoti, fra cui mia nonna Giuseppa
(Josephine) Casella nel 1890.
Belmonte e i Fasci
siciliani.
C'è una pagina della storia della
Sicilia e di Belmontedi cui, purtroppo, si parla poco. Mi riferisco
alla pagina dei Fasci siciliani, nonostante, l'ampia partecipazione
di noi belmontesi a tali accadimenti.
Questa non vuole essere la sede per
tentare di sciogliere nodi ancora insoluti che hanno interessato
quelle vicende; tuttavia, essendo fatti importanti nella storia
siciliana è importante saperne di più.
Intorno al 1891, nelle campagne della
Sicilia nacquero movimenti di lavoratori, al quale aderirono
contadini, operai, artigiani e intellettuali. Essi in 1° maggio
1891, data della fondazione ufficiale, vennero battezzati Fasci.
Sull'esempio dei fasci operai nati
nell'Italia centro-settentrionale, il movimento fu un tentativo di
riscatto delle classi meno abbienti e, inizialmente, era formato dal
proletariato urbano, a cui si aggiunsero braccianti agricoli,
"zolfatai" (minatori nelle miniere di zolfo), lavoratori
della marineria ed operai. Essi protestavano sia contro la proprietà
terriera siciliana, sia contro lo Stato che appoggiava apertamente la
classe benestante. La società in Sicilia era all'epoca molto
arretrata, il feudalesimo, sebbene abolito (dagli stessi
aristocratici illuminati) agli inizi del XIX secolo, aveva
condizionato la distribuzione delle terre e quindi delle ricchezze.
L'unità d'Italia, d'altro canto, non aveva portato i benefici
sociali sperati ed il malcontento covava fra i ceti più umili. Il
movimento chiedeva fondamentalmente delle riforme, soprattutto in
campo fiscale, ed una più avanzata normativa nell'ambito agrario,
che permettesse una revisione dei patti agrari (abolizione delle
gabelle) e la redistribuzione delle terre.
Le tensioni culminarono, il 20 gennaio
1893, con il massacro di Caltavuturo, dove, cinquecento contadini, di
ritorno dall'occupazione simbolica di alcune terre del demanio,
vennero dispersi da soldati e carabinieri armati di fucile, e tredici
manifestanti caddero vittime. «In un primo tempo», scrive don
Giuseppe Guarnieri, «la popolazione, nell'udire gli spari, pensò
trattarsi di mortaretti fatti scoppiare in onore di San Sebastiano,
ma ben presto fu chiara la tragica realtà di una inumana ed inutile
strage che poteva e doveva essere evitata».
A seguito di tale massacro furono
organizzate numerose manifestazioni di solidarietà sia da parte dei
Fasci, che sul piano nazionale, ed aumentò l'esasperazione dello
scontro sociale.
Il 21 e 22 maggio 1893 si tenne il
congresso di Palermo cui parteciparono 500 delegati di quasi 90 Fasci
e circoli socialisti. Venne eletto il Comitato Centrale, composto da
nove membri: Giacomo Montalto per la provincia di Trapani, Nicola
Petrina per la provincia di Messina, Giuseppe De Felice Giuffrida per
la provincia di Catania, Luigi Leone per la provincia di Siracusa,
Antonio Licata per la provincia di Girgenti, Agostino Lo Piano Pomar
per la provincia di Caltanissetta, Rosario Garibaldi Bosco, Nicola
Barbato e Bernardino Verro per la provincia di Palermo.
Vi chiederete, è Belmonte?
Nel maggio 1893, venne costituito il
Fascio di Belmonte Mezzagno, sotto la presidenza di Francesco
Italiano.
Il 14 luglio (anniversario della presa
della Bastiglia: 14 luglio 1789) si radunarono in contrada Petrosino,
vicino il paese, molti belmontesi per una manifestazione socialista.
Il 12 agosto venne organizzata una
manifestazione che vide come protagoniste una cinquantina di
compaesane.
L'indomani una delegazione di donne si
recò alla caserma dei carabinieri per chiedere l'abolizione del
dazio, la destituzione del Sindaco e lo scioglimento del Consiglio
comunale. Il 15 agosto, 600 contadini e contadine sfilarono per le
vie del paese. Questo pacifico corteo venne fatto sciogliere dal
Sindaco. Tutte le donne presenti alla manifestazione furono
arrestate.
Le manifestazioni di protesta,
sopratutto, quelle contro le amministrazioni comunali sono state
spesso represse con la forza, provocando morti e feriti.
Com'è finita? Male.
Infatti il presidente del consiglio, il
siciliano Crispi, adottò la linea dura con un intervento militare
comprendente esecuzioni sommarie e arresti di massa. Il movimento fu
sciolto nel 1894 e i capi vennero arrestati dal Commissario Regio
Roberto Morra di Lavriano. Il 30 maggio il tribunale militare di
Palermo condannò i fondatori a pesanti pene carcerarie: Giuseppe de
Felice Giuffrida a 18 anni di carcere, Rosario Bosco, Nicola Barbato
e Bernardino Verro a 12 anni di carcere quali capi e responsabili dei
Fasci siciliani. L'on. de Felice fu difeso in sede giudiziaria
dall'avvocato siciliano G.B. Impallomeni.
Il 14 marzo 1896, con un atto di
amnistia, venne concessa la clemenza a tutti i condannati in seguito
ai fatti dei fasci siciliani.
Chiudo affermando che: al di là del
giudizio degli storici, i Fasci siciliani sono stati un momento di
grande partecipazione popolare e, come tale andrebbe studiato meglio;
soprattutto durante il percorso di studi.
Emigrazione a Belmonte
Trattando di Storia di
Belmonte, non si può non parlare dei belmontesi che tra la fine
dell'Ottocento e gli inizi del Novecento decisero di lasciare il loro
paese, per cercare fortuna fuori dall'Italia.
I motivi che li spinsero a
partire sono da ricercare nella crisi economica che segui
l'unificazione d'Italia del 1861, tale crisi nacque da un notevole
aumento demografico. Questo portò ad una serie di insurrezioni
popolari dovute anche all'incomprensione e l'indifferenza della nuova
classe dirigente, per la nuova popolazione da loro amministrata,
l'aumento delle tasse e dei prezzi di beni di prima necessità;
l'aggravarsi della questione demaniale, dovuta all'opportunismo dei
ricchi proprietari terrieri. Le cause del malcontento vanno ricercate
proprio nella disperazione della maggior parte della popolazione
delusa nelle sue decennali attese di giustizia.
Le condizioni che hanno
favorito l’emigrazione siciliana, dipendono principalmente da uno
squilibrio tra ammontare della popolazione, scarsa disponibilità di
risorse produttive e condizioni di vita precarie.
Per analizzare il fenomeno
migratorio siciliano, occorre tener conto di più fattori.
In primo luogo, bisogna
tenere in considerazione le diverse condizioni, non solo economiche
ma anche culturali esistenti nelle diverse zone di partenza. In
secondo luogo bisogna prestare attenzione ai limiti normativi
dell’epoca.
Nei paesi fondati sul
latifondo, privi di una classe di piccoli proprietari, e in cui i
contadini erano costretti a subire ogni tipo di maltrattamento da
parte dei gabellotti, l’emigrazione inizia molto presto, già nella
seconda metà dell’Ottocento. Qui gli uomini vendono tutto quello
che possiedono per affidarsi ad un destino incerto che, in ogni caso,
non poteva mai essere peggiore di ciò che si lasciavano dietro.
Nelle zone in cui esisteva
la piccola e media proprietà, la situazione è certamente diversa.
Il migrante non vendeva le proprie proprietà, ma le affidava alla
moglie o ai parenti più vicini. Egli, infatti, intendeva ritornare
per investire le proprie fortune nel paese di origine allargando le
proprie proprietà o entrando a far parte del ceto di piccoli
proprietari.
Entrando nel dettaglio
dell'emigrazione belmontese il periodo preso in esame va dal 1892,
anno in cui i primi migranti lasciarono il paese, al 1924. Il numero
totale di belmontesi che migrarono in quegli anni è di 897; può
sembrare un numero esiguo ma non lo è, perché la popolazione
belmontese in quel periodo si aggirava intorno alle 4500 unità,
quindi la cifra rappresenta quasi il 20% della popolazione.
I luoghi di destinazione
principale furono: New York, con 401 unità; Pennsylvania, con 358
unità; più distanziate le altre mete, Missouri; Illinois; Ohio;
Kansas; Louisiana; Michigan e New Jersey.
Riguardo al genere, il 69%
furono gli uomini, quasi il 50% di questi erano manovali il restante
contadini; e il 31% donne, l'80% di esse casalinghe. Quindi furono le
persone più umili a lasciare il paese, la maggior parte di essi
fecero fortuna nel nuovo mondo.
Dobbiamo essere fieri dei
nostri emigranti perché dovunque andarono si fecero valere come
grandi lavoratori portando alto il nome di Belmonte Mezzagno nel
mondo.
Cappella delle Tre Croci
 Adesso approfondiremo le
nostre conoscenze della cappella delle Tre Croci:piccola perla
incastonata nel patrimonio culturale e religioso di Belmonte
Mezzagno.
Tutto nacque dalla devozione
e dalla fede di Pietro Chinnici: egli, infatti, ebbe nel 1912 -
stessi anni in cui furono sistemate le cappelle su pizzo Belmonte -
l'idea di costruire una piccola cappella nel sito; ultimo segno
belmontese nell'antica "scala" per Palermo.
La cappella fin da subito
entrò nel cuore dei Belmontesi, infatti, oltre alle cure di Pietro
Chinnici e della sua famiglia, tutti i belmontesi mostravano segni di
profonda devozione ad essa: Rosari, Sante Messe, lumini ed ex voto
non mancavano mai.
Col tempo la cappella
cominciò a mostrare segni degli anni che passavano. Questo - unito
ad una profonda devozione cresciuta dal conforto ricevuto dalle
preghiere davanti ad essa, riuscendo con la preghiera a vincere lo
sconforto della perdita della madre e di due figli - spinse il cugino
Crescentino Spera
Adesso approfondiremo le
nostre conoscenze della cappella delle Tre Croci:piccola perla
incastonata nel patrimonio culturale e religioso di Belmonte
Mezzagno.
Tutto nacque dalla devozione
e dalla fede di Pietro Chinnici: egli, infatti, ebbe nel 1912 -
stessi anni in cui furono sistemate le cappelle su pizzo Belmonte -
l'idea di costruire una piccola cappella nel sito; ultimo segno
belmontese nell'antica "scala" per Palermo.
La cappella fin da subito
entrò nel cuore dei Belmontesi, infatti, oltre alle cure di Pietro
Chinnici e della sua famiglia, tutti i belmontesi mostravano segni di
profonda devozione ad essa: Rosari, Sante Messe, lumini ed ex voto
non mancavano mai.
Col tempo la cappella
cominciò a mostrare segni degli anni che passavano. Questo - unito
ad una profonda devozione cresciuta dal conforto ricevuto dalle
preghiere davanti ad essa, riuscendo con la preghiera a vincere lo
sconforto della perdita della madre e di due figli - spinse il cugino
Crescentino Spera
(permettetemi di dire, l'eroico cugino "Tinuzzu)
nel 1974 a restaurarla. Da allora ogni anno, anche grazie alla sua
spinte, nel mese di maggio viene celebrata una messa nel sagrato
della cappella.
Prima Guerra Mondiale
Giunto è il momento di parlare della
Prima Guerra Mondiale e del ruolo che i giovani belmontesi hanno
rivestito nel combatterla e vincerla. Faremo questo in due modi:
-
raccontando la vita dello zio di
mia nonna - nipote di Stefano Casella - Damiano Casella, che, come
migliaia di suoi coetanei perse la vita nel conflitto, nel suo caso
durante la battaglia di Caporetto;
-
leggendo il diario di guerra del
fante Giuseppe Barrale, superstite del conflitto.

Damiano Casella
Damiano Casella nacque a Belmonte
Mezzagno da Giovanni e Melchiorra Traina il 21 gennaio 1892. Nel 1916
venne chiamato alle armi per andare sul fronte orientale, venne
inquadrato nella 753° compagnia mitraglieri FIAT Milano, durante la
XII battaglia dell'Isonzo - passata alla Storia come Caporetto - la
Brigata Milano venne assegnata al 159° reggimento fanteria XXVIII
Corpo d'Armata al comando del maggiore generale Alessandro Saporiti.
Con le sue grandi doti militari riuscì
a sopravvivere alla disfatta, però il destino fu barbaro e baro,
infatti, durante la ritirata i generali - proprio loro, i
responsabili della sconfitta - decisero di far saltare tutti i ponti
sull'Isonzo per evitare l'avanzata del nemico, senza aspettare che
non ci fosse nessuno sopra. Damiano trovatosi in uno di essi, salto
in aria con il ponte; ucciso dalle scellerate scelte del comando
italiano. Era il 27 ottobre 1917.
Prima di morire aveva scritto la sua
ultima lettera alla sorella: "Mia amabile sorella, ieri giuntami
con vero piacere la tua cartolina alla quale rimasi graditissimo del
tuo tenero affetto verso di me, ricordandoti il giorno beato della
nostra bella Santa Rosalia.
Inviata la tua bella cartolina, grazie
di cuore infinite per la tua bella cartolina a me con affetto
inviata.
Tu abbia un mare di baci, saluti
infiniti.
Tuo fratello, Casella Damiano."
Il Comune di Belmonte, riconoscente,
scrisse il suo nome fra i caduti nel monumento di piazza della
Libertà.
Siccome, nonostante le numerose
ricerche del compianto Gianni Casella (suo nipote) e poi dalle sue
anche le mie, non siamo riusciti a scoprire il luogo della sua
sepoltura, nulla mi leva dalla testa che lui sia il milite ignoto del
Vittoriano con due guardie che dal 1921 proteggono il suo riposo.
Giuseppe Barrale nacque a Belmonte
Mezzagno 8 luglio 1891 da Giuseppe e Giovanna Traina. Egli, pur
trovandosi sotto le bombe, il freddo e gli stenti della guerra, trovò
la forza di scrivere il suo diario di guerra, affinché a tutti noi
giungesse notizia di quanto stesse vivendo.
Il diario è scritto secondo le
capacità di un giovane contadino belmontese del 1915: con alcuni
errori ortografici e sintattici. Ma ciò conta relativamente, per
questo l'ho lasciato intatto come lui ce lo ha lasciato; ascolterete
i fatti direttamente dalla voce del protagonista.
Il diario è scaricabile dal link:
Madonna del Rosario
Tornando ai luoghi della spiritualità
belmontese, adesso tratteremo della Storia - a tratti prodigiosa -
della chiesetta Madonna del Rosario di Belmonte Mezzagno.
Tutto nasce dalla devozione ad un
quadro un po' particolare. Il dipinto, che ritrae la Madonna del
Rosario con accanto San Domenico in ginocchio, è stato trovato tra i
sassi nel terreno antistante la chiesetta (al di sotto della strada),
nel 1921 da dei contadini impegnati in lavori in quel fondo. Gli
operai lo calcolarono come una cianfrusaglia e lo posero con poco
interesse lontano da lì, l'indomani mattina, misteriosamente, il
quadro venne ritrovato nello stesso punto dove era stato trovato il
giorno prima. Non facendo particolare attenzione all'accaduto, i
contadini lo tolsero nuovamente da lì; l'indomani stessa storia: il
quadro di nuovo lì. A questo punto quegli uomini capendo che non si
trattava di un quadro come tutti gli altri, costruirono una cappella
- ancora rintracciabile all'interno della chiesa, entrando sulla
sinistra - e ve lo posero.
piccola chiesetta che ancora possiamo
ammirare, posizionando il quadro nell'abside.
I costruttori furono: Vischonte
Benedetto; La Barbera Francesco; Tumminia Sebastiano; Greco
Salvatore; Traina Francesco e Giuseppe; Chinnici Antonio; Martorana
Filippo e Greco Giuseppe.
Col passare degli anni, qualcuno decise
che sarebbe stato meglio posizionare nell'abside una statua che
riproducesse il soggetto del dipinto, cosi fecero: scavarono una
nicchia dietro l'altare, vi posero la statua coprendo l'abside con un
vetro, poi tolto, e misero il quadro in un piccolo altare laterale.
Nella chiesetta, ancora oggi nel mese
di maggio viene recitato quotidianamente il Rosario animato da
un'anziana signora belmontese (che ringrazio per le preziose
informazioni) che oltre a prendersi cura dell'aspetto estetico della
chiesetta, cosa ancora più importante ne cura la memoria.
Questa storia ricorda molto da vicino
gli avvenimenti che portarono alla costruzione della chiesa Madonna
del Rosario di Tagliavia: anche lì nacque tutto dal misterioso
ritrovamento di un quadro.
Pietro Allotta
Sulla Storia di Belmonte è d'obbligo
il ricordo del Maestro Pietro Allotta, di cui la banda ha preso il
nome.
Pietro Allotta, nacque a Belmonte
Mezzagno il 21.08.1892, dopo aver trascorso parecchi anni nell’ambito
delle bande militari palermitane, venne infatti nominato
sottufficiale, nel 1939 decise di dirigere la Banda Musicale di
Belmonte.
La sua opera fu instancabile; la sua
anima, ricca di espressione musicale, in breve tempo, fece parlare
alla nostra banda un nuovo linguaggio, più chiaro, più corretto e
più elegante.
Un fatto da rilevare, è l’orgoglio
dei belmontesi di quel periodo, infatti, i componenti erano tutti
belmontesi, ed il loro numero giunse a 50 elementi.
Anche l’archivio di brani, fino ad
allora molto povero, fu notevolmente arricchito dal maestro Allotta,
che portò insomma, un soffio di giovinezza nella vecchia banda. Non
poche volte, lo si vide, malato e anche in maniera grave, dirigere in
piazza con nelle espressioni del volto, il pallore della morte
prossima misto ad un’estasi musicale.
Morì il 01.12.1956 e fu un giorno di
particolare emozione per tutti i belmontesi.
Immacolata Concezione
Il momento culminante della religiosità
belmontese, è senza orma di dubbio l'Incontro di Pasqua. In questa
sede approfondiremo le origini della statua dell'Immacolata
utilizzata per tale evento.
La statua è stata comprata dalla
confraternita dell'Immacolata negli anni '30; si interessarono
dell'acquisto: Damiano Traina (mio bisnonno), Nino Santangelo e Totò
Santangelo. Questi intrepidi si recarono - pensò col treno - a
Lecce, dove la statua venne comperata; trasportarono il manichino in
un grande scatolone che venne aperto soltanto dopo l'arrivo a
Belmonte. Qui. con l'aiuto degli altri confrati, si montò il tutto
(tipo IKEA).
Rimaneva il problema del manto, di ciò
si occuparono il fratello e la sorella del mio avo (per la cronaca
Salvatore e Gaetana Traina) che da qualche tempo vivevano a
Philadelphia. Costoro inviarono, direttamente dalla Pennsylvania, il
tessuto per realizzare il manto, e le decorazioni per scrivere W. M.
in esso. Ebbene, incredibilmente, le decorazioni di oggi sono ancora
quelle originali degli anni '30.
Tornando al manto, per i primi incontri
si usò il tessuto quasi per com'era, ovvero, quadrato e un po'
corto. Successivamente venne modificato, finché si è potuto. Da
allora si sono susseguiti parecchi manti tutti, tranne quello
attualmente in uso, realizzati da mia nonna.
Mons. Francesco Pizzo
Mons. Francesco Pizzo nacque a Belmonte
Mezzagno il 16 1 1914 in una famiglia di fervente fede cattolica. Fin
da ragazzo il suo animo era diviso tra l’amore per Cristo e quello
per la letteratura, vocazioni che porterà a braccetto tutta la vita,
e che vivrà con infinita passione.
Laureatosi in Lettere Classiche, viene
ordinato sacerdote il 30 7 1944 dal Card. Luigi Lavitrano. Da subito
divenne assistente spirituale dell’Azione Cattolica di Belmonte, ma
questo impegno, che lui viveva con totale abnegazione, non gli impedì
di diventare insegnante di Lettere Latine- Greche e Storia al
Seminario di Palermo. I suoi allievi, ancora oggi, ricordano le sue
appassionate e commoventi letture dei “Promessi Sposi”.
Nel 1958 divenne Parroco di Belmonte,
in quel periodo l’Azione Cattolica belmontese visse il momento
migliore, diventando fucina di uomini che successivamente si
impegneranno sul campo socio-politico; sicuramente grazie al suo
input. Tengo a ricordare che durante il suo Parrocato è stata
rifatta la pavimentazione della Chiesa, in marmi bianchi di Carrara;
e sono stati posti i 14 quadri della Via Crucis.
Nel 1963 lascia la guida della
Parrocchia continuando a rimanere vicino alla comunità belmontese.
Nel 1965 divenne Direttore del Centro
Diocesano Vocazioni.
Dal 1980 fino al suo pensionamento, è
Canonico della Cattedrale di Palermo e Vicario del Card. Salvatore
Pappalardo.
Morirà nel 2002 lasciando un
indelebile ricordo di sé nel cuore dei belmontesi.
Belmonte
cinematografica
Belmonte Mezzagno è stata
per ben due volte set cinematografico. E' accaduto per le riprese dei
film Gelosia e Mafioso.
Gelosia è un film del 1953 prodotto da Excelsa film è distribuito da Medusa per la regia di Pietro Germi, con Erno Crisa e Marisa Belli; ispirato al romanzo del 1901 “Il marchese di Roccaverdina” di Luigi Capuana.
La storia è ambientata nell’ancora feudale Sicilia di fine ‘800: Antonio il marchese di Roccaverdina, andando quasi contronatura per i canoni dell’epoca, si innamora della giovane contadina Agrippina Solmo; non potendo sposarla, perché per l’epoca era impensabile che un marchese sposasse una sua contadina, l’accoglie nella sua dimora con la scusa di assumerla come cameriera ma in realtà fin da subito la sua Agrippina diventa per volontà del marchese la padrona di quella casa.
Per non dare scandalo agli occhi dei paesani, i quali già cominciavano a mormorare, escogita un piano: dare in sposa Agrippina al fedele fattore Rocco Criscione con l’obbligo che il matrimonio sia soltanto d’appartenenza e non d’amore, l’amore di Agrippina deve essere riversato soltanto verso di lui; i due accettano e si apprestano a sposarsi. Il marchese il giorno del matrimonio segue i due nell’ombra. Nel momento del sì, nota negli occhi di Rocco il lampo dell’amore; sentitosi tradito, nella strada che conduce in paese spara a Rocco uccidendolo. Tale delitto scatena una serie di eventi che porteranno il marchese alla follia…
Il film è stato girato interamente nel territorio di Belmonte Mezzagno e Bagheria. Le strade
di Belmonte presenti nelle riprese sono state: via Vallone Ponte; via Sancipirello; via Don Cesare e piazza Garibaldi. La località di campagna interessata è stata la "placa".
Pochi i protagonisti belmontesi, tra di loro, protagonista di una scena chiave – il passaggio sotto la finestra del marchese col carretto – è stato Totò Spera, ragazzo belmontese che morirà di lì a poco all’età di 22 anni.
Mafioso è un film del
1962 prodotto da Dino de Laurentis per la regia di Alberto Lattuada
con protagonista Alberto Sordi.
Il lungometraggio è
girato per un ampio tratto a Belmonte Mezzagno con brevi scene a
Bagheria all’interno di villa Palagonia e una scena sotto il
castello di Misilmeri. Il film comprende delle scene girate a
Manhattan, New york.
Molto semplice la trama:
Antonio Badalamenti è un caporeparto di una fabbrica di Milano; è
un superiore ligio al dovere e molto rigoroso con gli operai, per
questo è molto apprezzato dai dirigenti aziendali.
Tornato, dopo tanti anni,
a trascorrere le ferie estive nel suo paese siciliano d’origine:
Calamo – nome del paese frutto della fantasia del regista, che
assume le sembianze di Belmonte Mezzagno -; presenta la moglie Marta,
donna un po’ troppo emancipata per i canoni della Sicilia
dell’epoca, ai genitori che per questo la guardano con sospetto.
A Calamo rivede tutti gli
amici di gioventù, tra cui il boss del paese Don Vincenzo –
interpretato da Ugo Attanasio – a cui consegna un pacco che gli era
stato dato a Milano da amici italo-americani.
L’incontro con Don
Vincenzo stravolgerà la permanenza in Sicilia di Antonio, infatti lo
incarica – quasi a sua insaputa – di andare a New York a compiere
un atto che Antonio non avrebbe mai immaginato di dover compiere.
I luoghi belmontesi del
film sono: la casa con l’immagine di Maria nella facciata, situata
all’angolo tra via Sancipirello e via delle rose; corso martiri di
via Fani; via Giovanni Falcone e piazza Garibaldi con l’imponente
facciata della Chiesa Madre.
Tra i tanti protagonisti
belmontesi, ricordiamo Paolo Cuccia che interpretava il padre di
Antonio.
Per concludere, bisogna
ammettere che Lattuada disegna il ritratto di una Sicilia nenti
sacciu e lupara che forse non è mai esistita.
Matrimonio di una volta
In questo
capitolo parlerò di cosa è stato e come era vissuto il matrimonio
nella Belmonte e più in generale nella Sicilia di una volta.
La preparazione
del matrimonio cominciava, per la futura sposa, fin dalla più tenera
età; infatti, le madre e le nonne di tutte le bambine siciliane
cominciavano presto a preparare la "roba" (il corredo) per
la piccola.
Il fidanzarsi
non era semplicissimo perché le ragazze difficilmente avevano modo
di frequentare ragazzi loro coetanei. Il primo passo spettava
all'uomo: a lui toccava recarsi dal padre della donna di cui si era
innamorato per chiedergli di potersi fidanzare con la figlia. Il
padre, dopo aver valutato attentamente la "carata"
(condizione sociale) dell'aspirante fidanzato, decideva se per sua
figlia gli andava bene. Se il genitore era d'accordo si realizzava il
fidanzamento, non prima dell'incontro tra le famiglie il cosiddetto
"appuntamento". In questo incontro ci si accordava sui modi
e sui tempi in cui i due dovevano frequentarsi; sempre in casa della
fidanzata e per il tempo stabilito. Uscire da soli neanche a
parlarne.
"stimare la roba". Si fissava una data
nella quale il corredo veniva lavato e successivamente stirato da,
oltre alla madre della fidanzata, nonne, zie, cugine e parenti vari.
A tutto questo seguiva la "stima della roba", rito in qui
veniva mostrato l'intero corredo della futura sposa: lenzuola,
cuscini, federe, coperte, tende e tutto quello che serviva
all'arredamento di una casa; nel tutto era inclusa "a vesta ri
l'ottu iorna" (vestito degli otto giorni). Questa "roba"
veniva sistemata in una stanza della casa dei genitori di lei, e
adagiata sopra alcuni tavoli. Il tutto era arricchito dai regali che
la suocera aveva donato alla nuora, ed inoltre dai doni ricevuti dal
futuro sposo dai genitori di lei.
Dopo il
matrimonio, gli sposini trascorrevano sette giorni chiusi in casa,
all'ottavo giorno uscivano, con la sposa che indossava il relativo
abito, e andavano in casa di tutti i parenti per salutarli.
La trebbiatura
Ma vediamo nel
dettaglio cos'era la trebbiatura, operazione fondamentale per la
panificazione.
La trebbiatura
è il processo mediante il quale all’interno della spiga viene
separato il gambo, la paglia, dal preziosissimo grano, ovvero il
frutto.
Le spighe
mietute, chiamate “regni”, venivano portate nell'aia, in dialetto
siciliano “aria” (ampio spiazzo), per la loro separazione.
Anticamente l'operazione si svolgeva con gli asini o i cavalli
attraverso la cosiddetta "pisatina", che consisteva nel far
incedere gli animali sopra le spighe per far si che con il loro
calpestio riuscissero a far uscire il grano da esse; successivamente
si “spaiava”, ovvero si lanciavano in aria le spighe con l'uso di
lunghi bastoni in modo che, con l'aiuto di un alito di vento, il
grano rimanesse per terra e la paglia volasse più in la.
trebbia. Il funzionamento della medesima era abbastanza
semplice: nella parte superiore si inserivano le spighe e dalle due
estremità della trebbia uscivano rispettivamente il grano e la
paglia. I due prodotti seguivano percorsi differenti: la paglia
veniva spostata dal luogo dove cadeva e ammassata in un punto non
molto lontano, li veniva inserita in grandi sacchi, chiamati
"paggliuna"; e successivamente data in pasto agli animali.
Il grano veniva invece insaccato e conservato per poter, tutto
l’anno, preparare la farina e quindi il pane.
Per spostare la
paglia venivano usati dei muli bardati con un particolare tipo di
attacco, la "straula"; questa attrezzatura consentiva, con
un uomo in piedi su di essa, il trascinamento della medesima (la
paglia).
La panificazione
Passiamo adesso
alla panificazione, una volta vero e proprio rito.
Ottenuto il
grano con la trebbiatura, lo si portava al mulino e lì reso farina
che veniva portata in casa e lì conservata.
Nel giorno
della panificazione, che avveniva circa una volta a settimana, le
massaie all'alba si destavano, preparavano il quantitativo di farina
bastante per la quantità di pane prevista, e con essa si avviavano
dal fornaio.
Giunti lì, il
fornaio pesava la farina e, in base al peso, assegnava ad ognuno la
dose di lievito. Ricevuto il lievito, la massaia impastava la propria
farina e preparava i panetti che venivano riposti in appositi tavoli,
per farlo "rormiri", ovvero attendere che fosse completata
la fase di lievitazione. Giunto a lievitazione, ogni massaia metteva
nei panetti, prima che venissero infornati, un segno per
successivamente identificarlo: chi una fava, chi un legnetto, chi
altro.
Sfornato il
pane, ognuna delle donne rintracciava il suo pane, lo metteva nelle
"coffe" - ampie ceste - e lo portava a casa.
Anche, ma non
solo per questo, grazie al lungo lavoro che serviva per prepararlo,
il pane assumeva un valore sacro: non se ne buttava neanche una
mollica, e se ne cadeva un po' per terra lo si baciava e lo si
mangiava lo stesso; e se qualche bimbo non voleva mangiarlo, le nonne
lo rimproveravano dicendo: "mancia ca nno pani c'è u Signuri!"
Santa Croce
Ogni anno il 3 maggio, si ripete la
tradizione della salita alla Santa Croce (Pizzo Belmonte). La
tradizione di posizionare una croce nella montagna più alta è
comune a molti comuni della Sicilia, penso a Marineo, a Piana, ma è
presente anche in tantissimi altri comuni dell'isola.
Andando su Belmonte, credo che l'usanza
di salire il 3 maggio su Pizzo Belmonte risalga agli anni intorno al
1915, quando sono state posizionate le cappelle della via crucis.
Perchè il 3 maggio: perché in quella data, come il 14 settembre, la
Chiesa commemora da sempre la Santa Croce,
Per approfondire su questa importante
tradizione belmontese, racconterò l'origine dell'attuale Croce
presente in vetta.
Nell'estate del 1973, Gianni Casella,
compianto belmontese per tutta la vita vicino alla parrocchia, grazie
ad una colletta, riuscì a far costruire da un fabbro belmontese, una
croce di circa 140 chili per sostituire quella che già si trovava su
Pizzo Belmonte, piccola e quasi invisibile dal paese. Terminata la
sua costruzione, nacque un grave problema: come portarla in cima?
Gianni, da uomo assai concreto quale
era, trovò l'unica soluzione possibile: mio padre. Una mattina andò
a trovarlo esponendo il problema. Mio padre dopo aver un po'
riflettuto trovò il rimedio. Per il giorno stabilito organizzò una
piccolo team di quattro prestanti giovani belmontesi: oltre a lui; il
cognato Francesco Vaglica; l'amico di sempre Gaetano Di Liberto e
Vincenzo Romeo. Con loro caricò la Croce sul 616 grigio (il suo
camion), li fece salire sul cassone, Gianni si mise in cabina con lui
e partirono. Presero per valle funda, passarono contrada San
Salvatore e si diressero nel punto più vicino alla vetta distante
circa un chilometro. Giunti lì, i giovani e forti belmontesi,
presero la pesante Croce in spalla e via a piedi!
Capirete che percorrere un chilometro
in verticale tra le rocce di Pizzo Belmonte con 140 chili di croce
sulle spalle è un tantino complicato; ma il gruppo di temerari
riuscì nell'intento. Arrivati in vetta, conficcarono la Croce nel
fossetto che un altro volontario, l'omonimo di mio padre nonché
cugino Salvatore Spera, il giorno prima aveva scavato col
martelletto.
Quella sera, Gianni, per dar gioia ai
belmontesi, fece illuminare la Croce che per tutta la notte si poté
mirare dal paese.
Giuseppe Emanuele IV Ventimiglia Cottone principe di Belmonte
Morì a Parigi, ormai minato
irrimediabilmente dalla tisi, nell'ottobre del 1814.
I moti rivoluzionari del 1848-49
Nel gennaio del 1848, in Sicilia
scoppiò un'insurrezione popolare, a cui successivamente si aggiunse
la borghesia popolare, mossa soprattutto dalla volontà di
ripristinare la Costituzione del 1812. La rivoluzione siciliana
scoppiò il 12 gennaio 1848 in Piazza della Fieravecchia (oggi Piazza
Rivoluzione) a Palermo, capitanata da Giuseppe La Masa. Dopo
sanguinosi scontri, La Masa, al comando di un esercito popolare,
riuscì a scacciare la luogotenenza generale e gran parte
dell'esercito borbonico dalla Sicilia, costituendo un «comitato
generale rivoluzionario». Il comitato generale istituì un governo
provvisorio a Palermo; tra le felicitazioni generali e l'ottimismo,
Ruggero Settimo, un liberale moderato appartenente alla nobiltà
siciliana, venne nominato presidente. L'estensione del movimento
insurrezionale alla Campania ed al resto del regno fu immediato. Il
Re, dopo alcuni tentativi di frenare il movimento con caute
concessioni, cercò di arginare le richieste liberali concedendo la
Costituzione, per primo in Italia, con Regio Decreto del 29 gennaio.
La Costituzione venne promulgata l'11
febbraio e giurata il 24; Il 25 marzo del 1848 si riunì il
Parlamento Generale di Sicilia, con un governo rivoluzionario
presieduto da Ruggero Settimo e composto da ministri eletti dallo
stesso presidente, che proclamò l'indipendenza dell'isola,
nonostante l'appoggio concreto delle città siciliane al governo
provvisorio di Settimo, le aree rurali divennero scarsamente
controllate e agitazioni contadine misero in serie difficoltà le
amministrazioni locali. Re Ferdinando, approfittando di questo, non
fece tardare la sua reazione, decidendo di intraprendere una risoluta
restaurazione assolutistica.
Nel settembre 1848, dopo aver
richiamato in patria l'armata napoletana schierata in Lombardia ed
aver sospeso le attività parlamentari, il Re decise di reprimere con
la forza anche il separatismo siciliano, sopprimendo la rivoluzione e
il Parlamento che da questa era stato eletto.
La gente di Sicilia, man mano che
sentiva del ritorno dei Borbone, scappava di solito nelle montagne; e
i Borbone, non vedendo nei paesi la gente, pronta ad accoglierli,
distruggevano gli stessi paesi. Sorte che tocco a Belmonte Mezzagno.
Tutto cominciò il 7 maggio 1849 - già
da qualche giorno i belmontesi erano fuggiti sulle montagne - verso
le 7 di sera il generale Prono arrivò in paese con parte
dell'esercito borbonico, ad accoglierlo trovò soltanto l'economo
sacramentale Padre Luigi Mario Furitano, e il cappellano celebratario
della Chiesa Miseremini (Anime Sante) Padre Angelino Moltisanti (in
"nomen omen"). I due ministri andarono verso il Generale
offrendo pace assicurando la fedeltà del popolo belmontese a re
Ferdinando, affinché, il Generale non distruggesse il paese. Egli
accettò l'offerta, Padre Furitano, come segno di riconoscenza,
benedisse lui e l'esercito con l'ostensorio contenente il SS.
Sacramento.
Le paure del Reverendo l'indomani, 8
maggio 1849, purtroppo, si concretizzarono: squadre ribelli venute da
Palermo attaccarono i soldati nei monti intorno al paese, vedendo
questo il Generale, dopo aver scacciato i ribelli, ordinò la
distruzione del borgo. I soldati eseguirono l'ordine, lasciando in
piedi soltanto la Chiesa Madre e la Chiesa Miseremini.
L'esercito rimase in paese 7 giorni,
prima di rientrare a Palermo.
Quando l'esercito scomparve, i
belmontesi scesero dai monti trovando le proprie case ormai ridotte
in ceneri fumanti. Ai due Reverendi rimase l'orrore negli occhi e un
popolo da consolare.
Belmonte nell'unità d'Italia
Dopo la distruzione del paese per mano
delle truppe borboniche del 1848, con l'odio verso Ferdinando II che
non era mai stato così alto, cominciò la ricostruzione di Belmonte.
I belmontesi per la ricostruzione delle
proprie case non ricevettero alcun aiuto governativo, quindi,
nonostante il "Real" incendio delle campagne, dovettero
cavarsela da soli; ottennero soltanto di non pagare tasse. Ciò
solamente fino al 1850, quando i belmontesi ancora alla fame
dovettero ricominciare a pagare i tributi, per questo da quel giorno
Belmonte divenne uno dei principali centri organizzativi della
rivolta contro i Borbone. Tale odio cominciò a divenire movimento
organizzato nel febbraio 1853, quando furono organizzati convegni a
Parco (Altofonte), Belmonte, Mislmeri e Carini volti a preparare la
rivolta. Dopo vari tentativi, il momento giusto sembrò essere
arrivato il 4 aprile 1860, quando, a suono delle campane del convento
palermitano della Gancia, Francesco Riso e i suoi 84 compagni, fra i
quali numerosi belmontesi, tentarono con le armi di entrare nella
capitale. Il tentativo, anche a causa della scarsa efficacia delle
armi dei rivoltosi, falli ma fu il segnale che Garibaldi aspettava
...
Il 1° maggio 1860, dopo aver
raggruppato un migliaio di volontari, la maggior parte dei quali del
bergamasco, Garibaldi venuto a sapere del fermento rivoluzionario
siciliano, diede l'ordine di partire.
Nella notte tra il 4 e il 5 maggio,
Garibaldi e i "mille" salparono da Quarto su due piroscafi,
il Lombardo e il Piemonte, e, dopo una breve sosta nell'isola di
Talamone, l'11 maggio sbarcarono a Marsala. Il 15 maggio i
garibaldini si scontrarono a Calatafimi (TR) con le truppe
borboniche. Soprattutto a causa della scarsa preparazione degli
ufficiali borbonici, che fecero moltissimi errori di strategia; i
"mille" vinsero la battaglia e cominciarono ad avanzare
verso Palermo.
Nei territori limitrofi a Palermo,
cominciarono a sorgere truppe di irregolari a sostegno dei
garibaldini. Tali squadriglie erano gestite da La Masa, egli radunò
le truppe, forti di 5000 uomini provenienti da Belmonte, Mislmeri,
Mezzoiuso, Corleone e altri paesi del circondario,a Gibilrossa.
Belmonte Mezzagno, essendo il paese più vicino all'accampamento,
servì da base strategica delle operazioni.
Il 20 maggio Garibaldi, ormai giunto a
Misilmeri, volse alla volta di Belmonte in testa a 6000 uomini, che
lo accolse con entusiasmo. Il 24 maggio, nelle campagne di Belmonte
si svolse una sanguinosa battaglia fra le truppe borboniche e i
garibaldini in gran parte formati da belmontesi. L'esito fu funesto
per Garibaldi ma egli non si arrese, aiutato da La Masa il 25 maggio
spinse gli avamposti nelle alture di Belmonte e con esse l'indomani
sera inizio la discesa verso Palermo. Conquistata la città il 30
maggio, tutta la Sicilia venne rapidamente liberata; infatti, il 28
luglio l'ultimo soldato borbonico lasciò la Sicilia.
Il 21 ottobre 1860, anche a Belmonte si
svolse il plebiscito (il referendum) per l'annessione del paese al
nascente Regno d'Italia. Chiaramente le votazioni non avevano le
garanzie che oggi le contraddistinguono: non era garantita la
segretezza del voto, spesso espresso in modo palese con il sì spesso
estorto dai signorotti locali con modi assai poco democratici.
A Belmonte il popolo si espresse
favorevolmente all'annessione, più che altro perché credevano che
con i piemontesi non avrebbero più avuto fame; queste erano le
promesse. Molte di queste purtroppo vennero disattese causando
numerose rivolte, la più sanguinosa fu quella del 7 e mezzo del 15
settembre 1866; che in Sicilia causo oltre 25 mila morti.
La fame a Belmonte continuò ancora a
lungo e fu la principale causa della partecipazione del paese ai
fasci siciliani.
Stefano Casella
Adesso propongo
la storia di un belmontese dell'Ottocento. Tale approfondimento è
stato realizzato da una grande appassionata di storia belmontese
Joanna Calabrese Wilson, discendente come me del protagonista di
questa storia; si tratta di Stefano Casella (il vecchietto nella
foto), nato a Belmonte nel 1804 e morto nel 1892, di cui io per una
serie di vicissitudini porto il nome: suo nipote Stefano (che portava
il suo nome) era zio di mio nonno (fratello di sua madre Francesca
Casella) nonché suo padrino di battesimo, siccome mio nonno era il
più piccolo di 4 fratelli e una sorella lo chiamarono come il
padrino. Io, portando il nome di mio nonno, di conseguenza porto il
nome di Stefano Casella, suo bisnonno.
Ed ora ecco il contributo di
Joanna:
Stefano nacque nel 1804 a
Belmonte Mezzagno, in Sicilia, un paese insediato sulle colline fuori
Palermo. La vita del paese ruotava attorno a famiglia, fede e
agricoltura. Come molti ragazzi del paese, egli era figlio di un
contadino che crebbe per diventare contadino a sua volta. All’età
di 24 anni, Stefano sposò la diciannovenne Liboria D’Agostino.
Iniziarono subito la loro famiglia, e la piccola Giuseppa nacque
l’anno seguente.
Pandemia
Sfortunatamente, anche un
piccolo batterio di nome vibrio cholerae era appena agli inizi.
Prosperando nell’acqua da
bere contaminata, il colera si diffuse rapidamente in ampie sezioni
del globo, inclusa la Sicilia. La piccola Giuseppa di due anni fu la
prima a perire, nel 1831. Stefano e Liboria ebbero in seguito altri
sette figli, ma almeno due se ne andarono prima del 1840. Poi accade
l’impensabile: nell’estate del 1845, la stessa Liboria morì,
seguita il mese successivo da sua figlia di 10 mesi, Alfonsa.
Stefano era adesso un padre
solo con quattro figli da accudire. Fortunatamente, i suoi figli
sopravvissuti, dai 9 ai 14 anni, erano abbastanza grandi per aiutare
in casa e nei campi.
Rivoluzione Siciliana
La perdita personale di
Stefano aveva come sfondo una sommossa politica in Sicilia. La
crescente insoddisfazione nei confronti della casa reale dei Borboni
fu lo sprone di diverse rivoluzioni. La rivolta popolare del 1848 fu
ampiamente sostenuta a Belmonte Mezzagno. Per ritorsione, l’esercito
dei Borboni invase il villaggio l’8 maggio 1849, causando la fuga
degli abitanti del paese sulle colline. Il quarantaquattrenne Stefano
e i suoi figli si trovavano fra di loro. Tra i fuggiaschi sulle
colline si trovava anche la trentaduenne Eleonora Benigno con sua
figlia di otto anni, Giuseppa Capizzi. Proprio come Stefano, Eleonora
aveva perso il coniuge, Giovanni Capizzi, nel 1845, oltre a suo
figlio più giovane.
L’esercito dei Borboni
rimase per una settimana, per poi ritirarsi. Gli abitanti discesero
dalle colline e scoprirono che ogni edificio del paese era stato
ridotto in cenere, fatta eccezione per due chiese. Stefano e i suoi
figli dovettero ricominciare daccapo. Ancora una volta. Stessa cosa
per il resto di Belmonte, inclusa Eleonora e sua figlia.
Conforto
I documenti non rivelano
perché Stefano ed Eleonora finirono assieme. Forse compresero il
lutto e la perdita l’uno dell’altra come pochi altri potevano. A
prescindere dal motivo, si sposarono nel 1851. La famiglia allargata
comprendeva Stefano, Eleonora e i loro cinque figli superstiti. In
seguito ebbero altri figli propri, nominando i primi due come i loro
defunti coniugi, Liboria e Giovanni.
In attesa
La nuova famiglia Casella
non era però estranea al dramma. Nel 1856, la figlia allora
quindicenne di Eleonora, Giuseppa Capizzi, rimase incinta. Lei e il
figlio ventitreenne di Stefano, Giuseppe, desideravano sposarsi.
Questo presentò un dilemma più grande del solito perché Giuseppa
non aveva un padre in vita o un nonno che potesse dare il consenso al
matrimonio per la minorenne. Le autorità decisero di accettare il
permesso congiunto di Stefano ed Eleonora. Stefano scrisse nel suo
decreto di consenso che egli era “contenta chi il da lui figlio
Giuseppe Casella inguaggiare (legare con promessa di matrimonio) con
Giuseppa Capizzi.” Eleonora scrisse che era “contenta che la
detta di lei figlia Giuseppa Capizzi si pocca inguaggiare con indetto
Giuseppe Casella.”
“Contenta” e “contenta”
– quali meravigliose parole da sentire da Stefano ed Eleonora dopo
tutto quello che avevano sopportato. I fratellastri si sposarono il
28 luglio 1856, e la piccola Liboria (sì, un’altra Liboria) nacque
3 mesi più tardi – la prima nipote di molti per Stefano.
Ciò che hanno visto gli
occhi
Stefano Casella morì nel
1892 all’età di 87 anni. La sua vita abbracciò la gran parte del
19º secolo. Riuscii ad assistere - e forse a partecipare - alla
liberazione della Sicilia sotto Giuseppe Garibaldi, all’unificazione
dell’Italia, e ai progressi tecnologici come il trasporto su rotaie
e l’avvento della fotografia. Anche se Stefano attraversò calamità
inimmaginabili durante la prima metà della sua vita, alla fine
riuscì a vedere cambiare la sua terra natia, vide prosperare i suoi
figli e vide crescere i suoi nipoti. Riuscì a vivere anche per
accogliere l’arrivo dei bisnipoti, fra cui mia nonna Giuseppa
(Josephine) Casella nel 1890.
Belmonte e i Fasci siciliani.
C'è una pagina della storia della
Sicilia e di Belmontedi cui, purtroppo, si parla poco. Mi riferisco
alla pagina dei Fasci siciliani, nonostante, l'ampia partecipazione
di noi belmontesi a tali accadimenti.
Questa non vuole essere la sede per
tentare di sciogliere nodi ancora insoluti che hanno interessato
quelle vicende; tuttavia, essendo fatti importanti nella storia
siciliana è importante saperne di più.
Intorno al 1891, nelle campagne della
Sicilia nacquero movimenti di lavoratori, al quale aderirono
contadini, operai, artigiani e intellettuali. Essi in 1° maggio
1891, data della fondazione ufficiale, vennero battezzati Fasci.
Sull'esempio dei fasci operai nati
nell'Italia centro-settentrionale, il movimento fu un tentativo di
riscatto delle classi meno abbienti e, inizialmente, era formato dal
proletariato urbano, a cui si aggiunsero braccianti agricoli,
"zolfatai" (minatori nelle miniere di zolfo), lavoratori
della marineria ed operai. Essi protestavano sia contro la proprietà
terriera siciliana, sia contro lo Stato che appoggiava apertamente la
classe benestante. La società in Sicilia era all'epoca molto
arretrata, il feudalesimo, sebbene abolito (dagli stessi
aristocratici illuminati) agli inizi del XIX secolo, aveva
condizionato la distribuzione delle terre e quindi delle ricchezze.
L'unità d'Italia, d'altro canto, non aveva portato i benefici
sociali sperati ed il malcontento covava fra i ceti più umili. Il
movimento chiedeva fondamentalmente delle riforme, soprattutto in
campo fiscale, ed una più avanzata normativa nell'ambito agrario,
che permettesse una revisione dei patti agrari (abolizione delle
gabelle) e la redistribuzione delle terre.
Le tensioni culminarono, il 20 gennaio
1893, con il massacro di Caltavuturo, dove, cinquecento contadini, di
ritorno dall'occupazione simbolica di alcune terre del demanio,
vennero dispersi da soldati e carabinieri armati di fucile, e tredici
manifestanti caddero vittime. «In un primo tempo», scrive don
Giuseppe Guarnieri, «la popolazione, nell'udire gli spari, pensò
trattarsi di mortaretti fatti scoppiare in onore di San Sebastiano,
ma ben presto fu chiara la tragica realtà di una inumana ed inutile
strage che poteva e doveva essere evitata».
A seguito di tale massacro furono
organizzate numerose manifestazioni di solidarietà sia da parte dei
Fasci, che sul piano nazionale, ed aumentò l'esasperazione dello
scontro sociale.
Il 21 e 22 maggio 1893 si tenne il
congresso di Palermo cui parteciparono 500 delegati di quasi 90 Fasci
e circoli socialisti. Venne eletto il Comitato Centrale, composto da
nove membri: Giacomo Montalto per la provincia di Trapani, Nicola
Petrina per la provincia di Messina, Giuseppe De Felice Giuffrida per
la provincia di Catania, Luigi Leone per la provincia di Siracusa,
Antonio Licata per la provincia di Girgenti, Agostino Lo Piano Pomar
per la provincia di Caltanissetta, Rosario Garibaldi Bosco, Nicola
Barbato e Bernardino Verro per la provincia di Palermo.
Vi chiederete, è Belmonte?
Nel maggio 1893, venne costituito il
Fascio di Belmonte Mezzagno, sotto la presidenza di Francesco
Italiano.
Il 14 luglio (anniversario della presa
della Bastiglia: 14 luglio 1789) si radunarono in contrada Petrosino,
vicino il paese, molti belmontesi per una manifestazione socialista.
Il 12 agosto venne organizzata una
manifestazione che vide come protagoniste una cinquantina di
compaesane.
L'indomani una delegazione di donne si
recò alla caserma dei carabinieri per chiedere l'abolizione del
dazio, la destituzione del Sindaco e lo scioglimento del Consiglio
comunale. Il 15 agosto, 600 contadini e contadine sfilarono per le
vie del paese. Questo pacifico corteo venne fatto sciogliere dal
Sindaco. Tutte le donne presenti alla manifestazione furono
arrestate.
Le manifestazioni di protesta,
sopratutto, quelle contro le amministrazioni comunali sono state
spesso represse con la forza, provocando morti e feriti.
Com'è finita? Male.
Infatti il presidente del consiglio, il
siciliano Crispi, adottò la linea dura con un intervento militare
comprendente esecuzioni sommarie e arresti di massa. Il movimento fu
sciolto nel 1894 e i capi vennero arrestati dal Commissario Regio
Roberto Morra di Lavriano. Il 30 maggio il tribunale militare di
Palermo condannò i fondatori a pesanti pene carcerarie: Giuseppe de
Felice Giuffrida a 18 anni di carcere, Rosario Bosco, Nicola Barbato
e Bernardino Verro a 12 anni di carcere quali capi e responsabili dei
Fasci siciliani. L'on. de Felice fu difeso in sede giudiziaria
dall'avvocato siciliano G.B. Impallomeni.
Il 14 marzo 1896, con un atto di
amnistia, venne concessa la clemenza a tutti i condannati in seguito
ai fatti dei fasci siciliani.
Chiudo affermando che: al di là del
giudizio degli storici, i Fasci siciliani sono stati un momento di
grande partecipazione popolare e, come tale andrebbe studiato meglio;
soprattutto durante il percorso di studi.
Emigrazione a Belmonte
Trattando di Storia di
Belmonte, non si può non parlare dei belmontesi che tra la fine
dell'Ottocento e gli inizi del Novecento decisero di lasciare il loro
paese, per cercare fortuna fuori dall'Italia.
I motivi che li spinsero a
partire sono da ricercare nella crisi economica che segui
l'unificazione d'Italia del 1861, tale crisi nacque da un notevole
aumento demografico. Questo portò ad una serie di insurrezioni
popolari dovute anche all'incomprensione e l'indifferenza della nuova
classe dirigente, per la nuova popolazione da loro amministrata,
l'aumento delle tasse e dei prezzi di beni di prima necessità;
l'aggravarsi della questione demaniale, dovuta all'opportunismo dei
ricchi proprietari terrieri. Le cause del malcontento vanno ricercate
proprio nella disperazione della maggior parte della popolazione
delusa nelle sue decennali attese di giustizia.
Le condizioni che hanno
favorito l’emigrazione siciliana, dipendono principalmente da uno
squilibrio tra ammontare della popolazione, scarsa disponibilità di
risorse produttive e condizioni di vita precarie.
Per analizzare il fenomeno
migratorio siciliano, occorre tener conto di più fattori.
In primo luogo, bisogna
tenere in considerazione le diverse condizioni, non solo economiche
ma anche culturali esistenti nelle diverse zone di partenza. In
secondo luogo bisogna prestare attenzione ai limiti normativi
dell’epoca.
Nei paesi fondati sul
latifondo, privi di una classe di piccoli proprietari, e in cui i
contadini erano costretti a subire ogni tipo di maltrattamento da
parte dei gabellotti, l’emigrazione inizia molto presto, già nella
seconda metà dell’Ottocento. Qui gli uomini vendono tutto quello
che possiedono per affidarsi ad un destino incerto che, in ogni caso,
non poteva mai essere peggiore di ciò che si lasciavano dietro.
Nelle zone in cui esisteva
la piccola e media proprietà, la situazione è certamente diversa.
Il migrante non vendeva le proprie proprietà, ma le affidava alla
moglie o ai parenti più vicini. Egli, infatti, intendeva ritornare
per investire le proprie fortune nel paese di origine allargando le
proprie proprietà o entrando a far parte del ceto di piccoli
proprietari.
Entrando nel dettaglio
dell'emigrazione belmontese il periodo preso in esame va dal 1892,
anno in cui i primi migranti lasciarono il paese, al 1924. Il numero
totale di belmontesi che migrarono in quegli anni è di 897; può
sembrare un numero esiguo ma non lo è, perché la popolazione
belmontese in quel periodo si aggirava intorno alle 4500 unità,
quindi la cifra rappresenta quasi il 20% della popolazione.
I luoghi di destinazione
principale furono: New York, con 401 unità; Pennsylvania, con 358
unità; più distanziate le altre mete, Missouri; Illinois; Ohio;
Kansas; Louisiana; Michigan e New Jersey.
Riguardo al genere, il 69%
furono gli uomini, quasi il 50% di questi erano manovali il restante
contadini; e il 31% donne, l'80% di esse casalinghe. Quindi furono le
persone più umili a lasciare il paese, la maggior parte di essi
fecero fortuna nel nuovo mondo.
Dobbiamo essere fieri dei
nostri emigranti perché dovunque andarono si fecero valere come
grandi lavoratori portando alto il nome di Belmonte Mezzagno nel
mondo.
Cappella delle Tre Croci
 Adesso approfondiremo le
nostre conoscenze della cappella delle Tre Croci:piccola perla
incastonata nel patrimonio culturale e religioso di Belmonte
Mezzagno.
Adesso approfondiremo le
nostre conoscenze della cappella delle Tre Croci:piccola perla
incastonata nel patrimonio culturale e religioso di Belmonte
Mezzagno.
Tutto nacque dalla devozione
e dalla fede di Pietro Chinnici: egli, infatti, ebbe nel 1912 -
stessi anni in cui furono sistemate le cappelle su pizzo Belmonte -
l'idea di costruire una piccola cappella nel sito; ultimo segno
belmontese nell'antica "scala" per Palermo.
La cappella fin da subito
entrò nel cuore dei Belmontesi, infatti, oltre alle cure di Pietro
Chinnici e della sua famiglia, tutti i belmontesi mostravano segni di
profonda devozione ad essa: Rosari, Sante Messe, lumini ed ex voto
non mancavano mai.
Col tempo la cappella
cominciò a mostrare segni degli anni che passavano. Questo - unito
ad una profonda devozione cresciuta dal conforto ricevuto dalle
preghiere davanti ad essa, riuscendo con la preghiera a vincere lo
sconforto della perdita della madre e di due figli - spinse il cugino
Crescentino Spera
(permettetemi di dire, l'eroico cugino "Tinuzzu)
nel 1974 a restaurarla. Da allora ogni anno, anche grazie alla sua
spinte, nel mese di maggio viene celebrata una messa nel sagrato
della cappella.
Prima Guerra Mondiale
Giunto è il momento di parlare della
Prima Guerra Mondiale e del ruolo che i giovani belmontesi hanno
rivestito nel combatterla e vincerla. Faremo questo in due modi:
- raccontando la vita dello zio di mia nonna - nipote di Stefano Casella - Damiano Casella, che, come migliaia di suoi coetanei perse la vita nel conflitto, nel suo caso durante la battaglia di Caporetto;
- leggendo il diario di guerra del fante Giuseppe Barrale, superstite del conflitto.
 |
| Damiano Casella |
Con le sue grandi doti militari riuscì
a sopravvivere alla disfatta, però il destino fu barbaro e baro,
infatti, durante la ritirata i generali - proprio loro, i
responsabili della sconfitta - decisero di far saltare tutti i ponti
sull'Isonzo per evitare l'avanzata del nemico, senza aspettare che
non ci fosse nessuno sopra. Damiano trovatosi in uno di essi, salto
in aria con il ponte; ucciso dalle scellerate scelte del comando
italiano. Era il 27 ottobre 1917.
Prima di morire aveva scritto la sua
ultima lettera alla sorella: "Mia amabile sorella, ieri giuntami
con vero piacere la tua cartolina alla quale rimasi graditissimo del
tuo tenero affetto verso di me, ricordandoti il giorno beato della
nostra bella Santa Rosalia.
Inviata la tua bella cartolina, grazie
di cuore infinite per la tua bella cartolina a me con affetto
inviata.
Tu abbia un mare di baci, saluti
infiniti.
Tuo fratello, Casella Damiano."
Il Comune di Belmonte, riconoscente,
scrisse il suo nome fra i caduti nel monumento di piazza della
Libertà.
Siccome, nonostante le numerose
ricerche del compianto Gianni Casella (suo nipote) e poi dalle sue
anche le mie, non siamo riusciti a scoprire il luogo della sua
sepoltura, nulla mi leva dalla testa che lui sia il milite ignoto del
Vittoriano con due guardie che dal 1921 proteggono il suo riposo.
Giuseppe Barrale nacque a Belmonte
Mezzagno 8 luglio 1891 da Giuseppe e Giovanna Traina. Egli, pur
trovandosi sotto le bombe, il freddo e gli stenti della guerra, trovò
la forza di scrivere il suo diario di guerra, affinché a tutti noi
giungesse notizia di quanto stesse vivendo.
Il diario è scritto secondo le
capacità di un giovane contadino belmontese del 1915: con alcuni
errori ortografici e sintattici. Ma ciò conta relativamente, per
questo l'ho lasciato intatto come lui ce lo ha lasciato; ascolterete
i fatti direttamente dalla voce del protagonista.
Il diario è scaricabile dal link:
Madonna del Rosario
Tornando ai luoghi della spiritualità
belmontese, adesso tratteremo della Storia - a tratti prodigiosa -
della chiesetta Madonna del Rosario di Belmonte Mezzagno.
Tutto nasce dalla devozione ad un
quadro un po' particolare. Il dipinto, che ritrae la Madonna del
Rosario con accanto San Domenico in ginocchio, è stato trovato tra i
sassi nel terreno antistante la chiesetta (al di sotto della strada),
nel 1921 da dei contadini impegnati in lavori in quel fondo. Gli
operai lo calcolarono come una cianfrusaglia e lo posero con poco
interesse lontano da lì, l'indomani mattina, misteriosamente, il
quadro venne ritrovato nello stesso punto dove era stato trovato il
giorno prima. Non facendo particolare attenzione all'accaduto, i
contadini lo tolsero nuovamente da lì; l'indomani stessa storia: il
quadro di nuovo lì. A questo punto quegli uomini capendo che non si
trattava di un quadro come tutti gli altri, costruirono una cappella
- ancora rintracciabile all'interno della chiesa, entrando sulla
sinistra - e ve lo posero.
piccola chiesetta che ancora possiamo
ammirare, posizionando il quadro nell'abside.
I costruttori furono: Vischonte
Benedetto; La Barbera Francesco; Tumminia Sebastiano; Greco
Salvatore; Traina Francesco e Giuseppe; Chinnici Antonio; Martorana
Filippo e Greco Giuseppe.
Col passare degli anni, qualcuno decise
che sarebbe stato meglio posizionare nell'abside una statua che
riproducesse il soggetto del dipinto, cosi fecero: scavarono una
nicchia dietro l'altare, vi posero la statua coprendo l'abside con un
vetro, poi tolto, e misero il quadro in un piccolo altare laterale.
Nella chiesetta, ancora oggi nel mese
di maggio viene recitato quotidianamente il Rosario animato da
un'anziana signora belmontese (che ringrazio per le preziose
informazioni) che oltre a prendersi cura dell'aspetto estetico della
chiesetta, cosa ancora più importante ne cura la memoria.
Questa storia ricorda molto da vicino
gli avvenimenti che portarono alla costruzione della chiesa Madonna
del Rosario di Tagliavia: anche lì nacque tutto dal misterioso
ritrovamento di un quadro.
Pietro Allotta
Sulla Storia di Belmonte è d'obbligo
il ricordo del Maestro Pietro Allotta, di cui la banda ha preso il
nome.
Pietro Allotta, nacque a Belmonte
Mezzagno il 21.08.1892, dopo aver trascorso parecchi anni nell’ambito
delle bande militari palermitane, venne infatti nominato
sottufficiale, nel 1939 decise di dirigere la Banda Musicale di
Belmonte.
La sua opera fu instancabile; la sua
anima, ricca di espressione musicale, in breve tempo, fece parlare
alla nostra banda un nuovo linguaggio, più chiaro, più corretto e
più elegante.
Un fatto da rilevare, è l’orgoglio
dei belmontesi di quel periodo, infatti, i componenti erano tutti
belmontesi, ed il loro numero giunse a 50 elementi.
Anche l’archivio di brani, fino ad
allora molto povero, fu notevolmente arricchito dal maestro Allotta,
che portò insomma, un soffio di giovinezza nella vecchia banda. Non
poche volte, lo si vide, malato e anche in maniera grave, dirigere in
piazza con nelle espressioni del volto, il pallore della morte
prossima misto ad un’estasi musicale.
Morì il 01.12.1956 e fu un giorno di
particolare emozione per tutti i belmontesi.
Immacolata Concezione
Il momento culminante della religiosità
belmontese, è senza orma di dubbio l'Incontro di Pasqua. In questa
sede approfondiremo le origini della statua dell'Immacolata
utilizzata per tale evento.
La statua è stata comprata dalla
confraternita dell'Immacolata negli anni '30; si interessarono
dell'acquisto: Damiano Traina (mio bisnonno), Nino Santangelo e Totò
Santangelo. Questi intrepidi si recarono - pensò col treno - a
Lecce, dove la statua venne comperata; trasportarono il manichino in
un grande scatolone che venne aperto soltanto dopo l'arrivo a
Belmonte. Qui. con l'aiuto degli altri confrati, si montò il tutto
(tipo IKEA).
Rimaneva il problema del manto, di ciò
si occuparono il fratello e la sorella del mio avo (per la cronaca
Salvatore e Gaetana Traina) che da qualche tempo vivevano a
Philadelphia. Costoro inviarono, direttamente dalla Pennsylvania, il
tessuto per realizzare il manto, e le decorazioni per scrivere W. M.
in esso. Ebbene, incredibilmente, le decorazioni di oggi sono ancora
quelle originali degli anni '30.
Tornando al manto, per i primi incontri
si usò il tessuto quasi per com'era, ovvero, quadrato e un po'
corto. Successivamente venne modificato, finché si è potuto. Da
allora si sono susseguiti parecchi manti tutti, tranne quello
attualmente in uso, realizzati da mia nonna.
Mons. Francesco Pizzo
Mons. Francesco Pizzo nacque a Belmonte
Mezzagno il 16 1 1914 in una famiglia di fervente fede cattolica. Fin
da ragazzo il suo animo era diviso tra l’amore per Cristo e quello
per la letteratura, vocazioni che porterà a braccetto tutta la vita,
e che vivrà con infinita passione.
Laureatosi in Lettere Classiche, viene
ordinato sacerdote il 30 7 1944 dal Card. Luigi Lavitrano. Da subito
divenne assistente spirituale dell’Azione Cattolica di Belmonte, ma
questo impegno, che lui viveva con totale abnegazione, non gli impedì
di diventare insegnante di Lettere Latine- Greche e Storia al
Seminario di Palermo. I suoi allievi, ancora oggi, ricordano le sue
appassionate e commoventi letture dei “Promessi Sposi”.
Nel 1958 divenne Parroco di Belmonte,
in quel periodo l’Azione Cattolica belmontese visse il momento
migliore, diventando fucina di uomini che successivamente si
impegneranno sul campo socio-politico; sicuramente grazie al suo
input. Tengo a ricordare che durante il suo Parrocato è stata
rifatta la pavimentazione della Chiesa, in marmi bianchi di Carrara;
e sono stati posti i 14 quadri della Via Crucis.
Nel 1963 lascia la guida della
Parrocchia continuando a rimanere vicino alla comunità belmontese.
Nel 1965 divenne Direttore del Centro
Diocesano Vocazioni.
Dal 1980 fino al suo pensionamento, è
Canonico della Cattedrale di Palermo e Vicario del Card. Salvatore
Pappalardo.
Morirà nel 2002 lasciando un
indelebile ricordo di sé nel cuore dei belmontesi.
Belmonte
cinematografica
Belmonte Mezzagno è stata
per ben due volte set cinematografico. E' accaduto per le riprese dei
film Gelosia e Mafioso.
La storia è ambientata nell’ancora feudale Sicilia di fine ‘800: Antonio il marchese di Roccaverdina, andando quasi contronatura per i canoni dell’epoca, si innamora della giovane contadina Agrippina Solmo; non potendo sposarla, perché per l’epoca era impensabile che un marchese sposasse una sua contadina, l’accoglie nella sua dimora con la scusa di assumerla come cameriera ma in realtà fin da subito la sua Agrippina diventa per volontà del marchese la padrona di quella casa.
Per non dare scandalo agli occhi dei paesani, i quali già cominciavano a mormorare, escogita un piano: dare in sposa Agrippina al fedele fattore Rocco Criscione con l’obbligo che il matrimonio sia soltanto d’appartenenza e non d’amore, l’amore di Agrippina deve essere riversato soltanto verso di lui; i due accettano e si apprestano a sposarsi. Il marchese il giorno del matrimonio segue i due nell’ombra. Nel momento del sì, nota negli occhi di Rocco il lampo dell’amore; sentitosi tradito, nella strada che conduce in paese spara a Rocco uccidendolo. Tale delitto scatena una serie di eventi che porteranno il marchese alla follia…
Il film è stato girato interamente nel territorio di Belmonte Mezzagno e Bagheria. Le strade
Pochi i protagonisti belmontesi, tra di loro, protagonista di una scena chiave – il passaggio sotto la finestra del marchese col carretto – è stato Totò Spera, ragazzo belmontese che morirà di lì a poco all’età di 22 anni.
Mafioso è un film del
1962 prodotto da Dino de Laurentis per la regia di Alberto Lattuada
con protagonista Alberto Sordi.
Il lungometraggio è
girato per un ampio tratto a Belmonte Mezzagno con brevi scene a
Bagheria all’interno di villa Palagonia e una scena sotto il
castello di Misilmeri. Il film comprende delle scene girate a
Manhattan, New york.
Molto semplice la trama:
Antonio Badalamenti è un caporeparto di una fabbrica di Milano; è
un superiore ligio al dovere e molto rigoroso con gli operai, per
questo è molto apprezzato dai dirigenti aziendali.
Tornato, dopo tanti anni,
a trascorrere le ferie estive nel suo paese siciliano d’origine:
Calamo – nome del paese frutto della fantasia del regista, che
assume le sembianze di Belmonte Mezzagno -; presenta la moglie Marta,
donna un po’ troppo emancipata per i canoni della Sicilia
dell’epoca, ai genitori che per questo la guardano con sospetto.
A Calamo rivede tutti gli
amici di gioventù, tra cui il boss del paese Don Vincenzo –
interpretato da Ugo Attanasio – a cui consegna un pacco che gli era
stato dato a Milano da amici italo-americani.
L’incontro con Don
Vincenzo stravolgerà la permanenza in Sicilia di Antonio, infatti lo
incarica – quasi a sua insaputa – di andare a New York a compiere
un atto che Antonio non avrebbe mai immaginato di dover compiere.
I luoghi belmontesi del
film sono: la casa con l’immagine di Maria nella facciata, situata
all’angolo tra via Sancipirello e via delle rose; corso martiri di
via Fani; via Giovanni Falcone e piazza Garibaldi con l’imponente
facciata della Chiesa Madre.
Tra i tanti protagonisti
belmontesi, ricordiamo Paolo Cuccia che interpretava il padre di
Antonio.
Per concludere, bisogna
ammettere che Lattuada disegna il ritratto di una Sicilia nenti
sacciu e lupara che forse non è mai esistita.
In questo
capitolo parlerò di cosa è stato e come era vissuto il matrimonio
nella Belmonte e più in generale nella Sicilia di una volta.
La preparazione
del matrimonio cominciava, per la futura sposa, fin dalla più tenera
età; infatti, le madre e le nonne di tutte le bambine siciliane
cominciavano presto a preparare la "roba" (il corredo) per
la piccola.
Il fidanzarsi
non era semplicissimo perché le ragazze difficilmente avevano modo
di frequentare ragazzi loro coetanei. Il primo passo spettava
all'uomo: a lui toccava recarsi dal padre della donna di cui si era
innamorato per chiedergli di potersi fidanzare con la figlia. Il
padre, dopo aver valutato attentamente la "carata"
(condizione sociale) dell'aspirante fidanzato, decideva se per sua
figlia gli andava bene. Se il genitore era d'accordo si realizzava il
fidanzamento, non prima dell'incontro tra le famiglie il cosiddetto
"appuntamento". In questo incontro ci si accordava sui modi
e sui tempi in cui i due dovevano frequentarsi; sempre in casa della
fidanzata e per il tempo stabilito. Uscire da soli neanche a
parlarne.
"stimare la roba". Si fissava una data
nella quale il corredo veniva lavato e successivamente stirato da,
oltre alla madre della fidanzata, nonne, zie, cugine e parenti vari.
A tutto questo seguiva la "stima della roba", rito in qui
veniva mostrato l'intero corredo della futura sposa: lenzuola,
cuscini, federe, coperte, tende e tutto quello che serviva
all'arredamento di una casa; nel tutto era inclusa "a vesta ri
l'ottu iorna" (vestito degli otto giorni). Questa "roba"
veniva sistemata in una stanza della casa dei genitori di lei, e
adagiata sopra alcuni tavoli. Il tutto era arricchito dai regali che
la suocera aveva donato alla nuora, ed inoltre dai doni ricevuti dal
futuro sposo dai genitori di lei.
Dopo il
matrimonio, gli sposini trascorrevano sette giorni chiusi in casa,
all'ottavo giorno uscivano, con la sposa che indossava il relativo
abito, e andavano in casa di tutti i parenti per salutarli.
La trebbiatura
Ma vediamo nel
dettaglio cos'era la trebbiatura, operazione fondamentale per la
panificazione.
La trebbiatura
è il processo mediante il quale all’interno della spiga viene
separato il gambo, la paglia, dal preziosissimo grano, ovvero il
frutto.
Le spighe
mietute, chiamate “regni”, venivano portate nell'aia, in dialetto
siciliano “aria” (ampio spiazzo), per la loro separazione.
Anticamente l'operazione si svolgeva con gli asini o i cavalli
attraverso la cosiddetta "pisatina", che consisteva nel far
incedere gli animali sopra le spighe per far si che con il loro
calpestio riuscissero a far uscire il grano da esse; successivamente
si “spaiava”, ovvero si lanciavano in aria le spighe con l'uso di
lunghi bastoni in modo che, con l'aiuto di un alito di vento, il
grano rimanesse per terra e la paglia volasse più in la.
trebbia. Il funzionamento della medesima era abbastanza
semplice: nella parte superiore si inserivano le spighe e dalle due
estremità della trebbia uscivano rispettivamente il grano e la
paglia. I due prodotti seguivano percorsi differenti: la paglia
veniva spostata dal luogo dove cadeva e ammassata in un punto non
molto lontano, li veniva inserita in grandi sacchi, chiamati
"paggliuna"; e successivamente data in pasto agli animali.
Il grano veniva invece insaccato e conservato per poter, tutto
l’anno, preparare la farina e quindi il pane.
Per spostare la
paglia venivano usati dei muli bardati con un particolare tipo di
attacco, la "straula"; questa attrezzatura consentiva, con
un uomo in piedi su di essa, il trascinamento della medesima (la
paglia).
La panificazione
Passiamo adesso
alla panificazione, una volta vero e proprio rito.
Ottenuto il
grano con la trebbiatura, lo si portava al mulino e lì reso farina
che veniva portata in casa e lì conservata.
Nel giorno
della panificazione, che avveniva circa una volta a settimana, le
massaie all'alba si destavano, preparavano il quantitativo di farina
bastante per la quantità di pane prevista, e con essa si avviavano
dal fornaio.
Giunti lì, il
fornaio pesava la farina e, in base al peso, assegnava ad ognuno la
dose di lievito. Ricevuto il lievito, la massaia impastava la propria
farina e preparava i panetti che venivano riposti in appositi tavoli,
per farlo "rormiri", ovvero attendere che fosse completata
la fase di lievitazione. Giunto a lievitazione, ogni massaia metteva
nei panetti, prima che venissero infornati, un segno per
successivamente identificarlo: chi una fava, chi un legnetto, chi
altro.
Sfornato il
pane, ognuna delle donne rintracciava il suo pane, lo metteva nelle
"coffe" - ampie ceste - e lo portava a casa.
Anche, ma non
solo per questo, grazie al lungo lavoro che serviva per prepararlo,
il pane assumeva un valore sacro: non se ne buttava neanche una
mollica, e se ne cadeva un po' per terra lo si baciava e lo si
mangiava lo stesso; e se qualche bimbo non voleva mangiarlo, le nonne
lo rimproveravano dicendo: "mancia ca nno pani c'è u Signuri!"
Santa Croce
Ogni anno il 3 maggio, si ripete la
tradizione della salita alla Santa Croce (Pizzo Belmonte). La
tradizione di posizionare una croce nella montagna più alta è
comune a molti comuni della Sicilia, penso a Marineo, a Piana, ma è
presente anche in tantissimi altri comuni dell'isola.
Andando su Belmonte, credo che l'usanza
di salire il 3 maggio su Pizzo Belmonte risalga agli anni intorno al
1915, quando sono state posizionate le cappelle della via crucis.
Perchè il 3 maggio: perché in quella data, come il 14 settembre, la
Chiesa commemora da sempre la Santa Croce,
Per approfondire su questa importante
tradizione belmontese, racconterò l'origine dell'attuale Croce
presente in vetta.
Nell'estate del 1973, Gianni Casella,
compianto belmontese per tutta la vita vicino alla parrocchia, grazie
ad una colletta, riuscì a far costruire da un fabbro belmontese, una
croce di circa 140 chili per sostituire quella che già si trovava su
Pizzo Belmonte, piccola e quasi invisibile dal paese. Terminata la
sua costruzione, nacque un grave problema: come portarla in cima?
Gianni, da uomo assai concreto quale
era, trovò l'unica soluzione possibile: mio padre. Una mattina andò
a trovarlo esponendo il problema. Mio padre dopo aver un po'
riflettuto trovò il rimedio. Per il giorno stabilito organizzò una
piccolo team di quattro prestanti giovani belmontesi: oltre a lui; il
cognato Francesco Vaglica; l'amico di sempre Gaetano Di Liberto e
Vincenzo Romeo. Con loro caricò la Croce sul 616 grigio (il suo
camion), li fece salire sul cassone, Gianni si mise in cabina con lui
e partirono. Presero per valle funda, passarono contrada San
Salvatore e si diressero nel punto più vicino alla vetta distante
circa un chilometro. Giunti lì, i giovani e forti belmontesi,
presero la pesante Croce in spalla e via a piedi!
Capirete che percorrere un chilometro
in verticale tra le rocce di Pizzo Belmonte con 140 chili di croce
sulle spalle è un tantino complicato; ma il gruppo di temerari
riuscì nell'intento. Arrivati in vetta, conficcarono la Croce nel
fossetto che un altro volontario, l'omonimo di mio padre nonché
cugino Salvatore Spera, il giorno prima aveva scavato col
martelletto.
Quella sera, Gianni, per dar gioia ai
belmontesi, fece illuminare la Croce che per tutta la notte si poté
mirare dal paese.























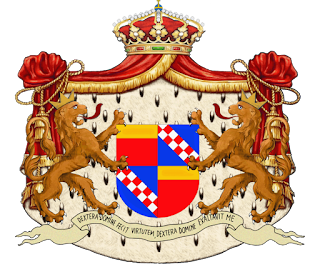

Complimenti all'autore, grazie 💗
RispondiEliminabravissimo, mi ha fatto rivivere ricordi dei miei avi e miei....Belmonte terra dei miei avi materni....grazie.Francesca.
RispondiEliminaStefano, forse oggi saresti l'unico che potrebbe rispondere a questa domanda: qual è l'anno di fondazione della scuola pubblica a Belmonte? Questa tua storia di Belmonte, che ho appena riletto, è la più completa in assoluto. A noi belmontesi manchi tantissimo
RispondiElimina